AGGIORNAMENTI
Cerca
Settimo torinese
23 Aprile 2023 - 10:16
IN FOTO Anna Caterina Testa, classe 1926
Anna Caterina Testa mi accoglie con un sorriso sulla porta di casa, all’estrema periferia di Settimo Torinese, nei pressi dell’autostrada per Milano. È un’elegante signora dai modi garbati e amabili: si esprime in piemontese, con una semplicità che incanta, ricorrendo a parole dal sapore arcaico. Assolutamente non dimostra i suoi novantasei anni. Ma, sedutasi al tavolo della cucina, il suo sorriso si spegne. Perché Anna Caterina custodisce una terribile storia. Una storia di dolore e di morte della quale fu involontaria protagonista in giovanissima età, nel periodo più fosco della guerra di liberazione, quando la vita umana contava poco più di nulla.
Anna Caterina è nata nel 1926. I suoi genitori, Carlo Testa e Teresa Veronello, risiedevano a Collegno e avevano già un figlio, Alessandro, venuto alla luce un paio di anni prima, il 3 luglio 1924. Con i due fratelli, sin da piccoli, il destino si mostrò decisamente ingeneroso. Rimasti orfani, i ragazzi furono avviati assai presto al lavoro. Alessandro ebbe un posto da garzone in una cascina di Mezzi Po, allora nel territorio comunale di Gassino. Di lì a qualche tempo, la sorella si trasferì a Settimo, avendo trovato impiego come ragazza di servizio presso una famiglia del luogo.
IN FOTO Il crocifisso che Alessandro Testa stringeva in pugno quando venne fucilato a Torino
Un dilemma che vale la vita
Chiamato alle armi, Alessandro Testa fu arruolato nella Guardia alla frontiera, il corpo militare istituito nel 1937 per la difesa dei confini italiani. L’8 settembre 1943, quando la radio diffuse la notizia dell’armistizio sottoscritto dal governo del maresciallo Pietro Badoglio con gli Alleati, il giovane si trovava a Sauze d’Oulx. Per sfuggire ai tedeschi, credette bene di riparare al di là delle Alpi con alcuni suoi commilitoni, ma i maquis francesi lo respinsero. Così decise di trasferirsi a Settimo dove trovò un lavoro e un rifugio presso il caseificio Gobetto, in località Provinciale, quindi nuovamente ai Mezzi di Gassino. Intanto si moltiplicavano gli appelli per la coscrizione obbligatoria nell’esercito della Repubblica sociale. Alle prese con un problematico dilemma morale, il giovane scelse di unirsi ai partigiani della 17a brigata garibaldina «Felice Cima». Era il 10 giugno 1944, come risulta dai documenti conservati presso l’Archivio centrale dello Stato.
Le reminiscenze del tempo trascorso si affollano alla mente di Anna Caterina. «Alessandro – afferma – mi assomigliava. Gli piaceva il lavoro in campagna e non amava mettersi in mostra. Non era affatto un “blagheur” (vanitoso, in piemontese)». «Testa è amante della natura, del sole, degli astri, conosce le fasi lunari, il nome delle piante, degli animali, degli uccelli, e con questo spirito contadino […] sceglie […] di lottare per la libertà», spiegò Giovanni Boccardo, il partigiano Vinicio, in un commosso ricordo dell’aprile 2000. La Val Casternone, ai piedi del Musinè, da Val della Torre alle Grange di Brione, sino a San Gillio, costituirà la zona operativa del giovane resistente.
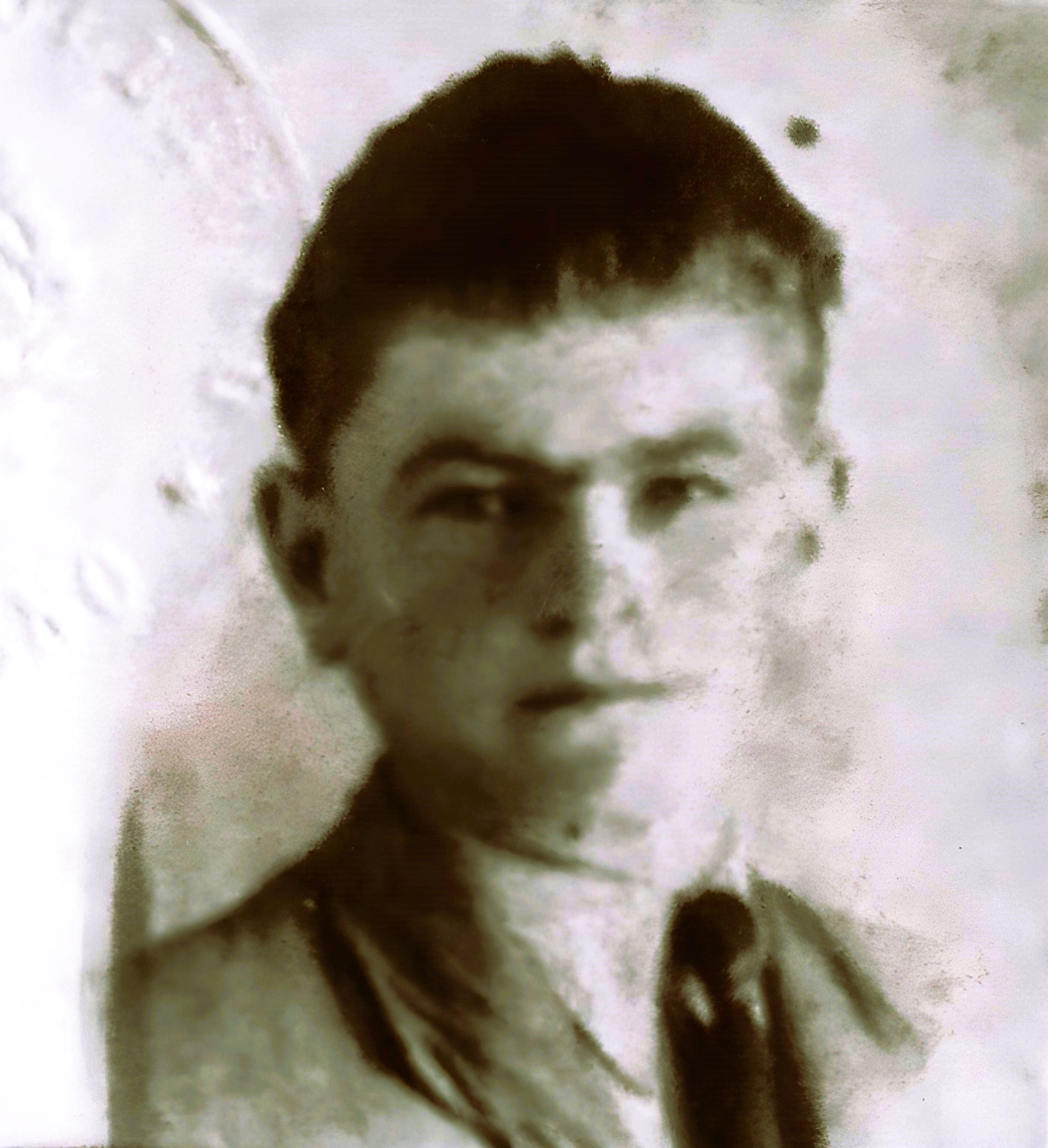
IN FOTO Alessandro Testa fucilato al Martinetto di Torino il 15 dicembre 1944
Sennonché l’esperienza partigiana di Testa si rivelerà di breve durata. Catturato dai fascisti nel corso di un rastrellamento, sarà condotto nella caserma «Alessandro La Marmora», a Torino (via Asti), dove aveva sede l’Ufficio politico investigativo della Guardia nazionale repubblicana (ma la sorella sostiene che fu rinchiuso nella caserma «Giovanni Cavalli»). Tradotto alle Carceri nuove, il giovane comparve davanti al Tribunale militare di guerra che operava presso il comando del Corpo controguerriglia (il famigerato Cogu). I giudici erano competenti per una numerosa serie di gravi reati: rapporti con i prigionieri di guerra e gli internati civili, appartenenza a bande di ribelli, diffusione di materiale propagandistico contro le forze armate della Repubblica sociale, detenzione non autorizzata di apparecchi radiotrasmittenti, omessa osservanza di ordini militari, renitenza alla leva, soccorso ai disertori e così via. Il ragazzo dal volto imberbe e dallo sguardo triste aveva più di una ragione per essere inquieto.
«Il rauco stridore delle chiavi»
Assieme a Testa furono processati altri due giovani, presumibilmente presi durante il medesimo rastrellamento: il meccanico ventiduenne Giuseppe Berta, artigliere alpino, originario di Nizza Monferrato, però residente ad Alpignano, anch’egli della brigata «Felice Cima», e lo studente diciannovenne Alfredo Attardi, siciliano di Enna, ex milite fascista, quindi partigiano della 41a brigata garibaldina «Carlo Carli». Per tutti, la sentenza fu di morte. I tre si appellarono alla clemenza di Mussolini, ma le domande di grazia non perverranno mai sulla scrivania del Duce. Ad Alessandro non rimase che riferire l’agghiacciante notizia alla sorella, recatasi in carcere per portargli qualche capo di biancheria pulita.
Quando Berta, Testa e Attardi videro i padri francescani Ruggero Cipolla e Raffaele D’Elia entrare nella loro cella, compresero che ogni speranza era vana. Riferì il buon frate Ruggero che confortò decine di condannati a morte durante la guerra di liberazione: «L’Attardi, siciliano, riempiva la cella con i suoi richiami. Testa, contadino di Collegno, lo guardava un po’ stupito e, in fondo, crucciato che gli impedisse di pensare a se stesso. Berta chiedeva di scrivere alla mamma e alla moglie, cui raccomandava la creaturina che avrebbe dovuto veder la luce di lì a pochi giorni».
Poi, per ricorrere ancora alle espressioni di padre Ruggero, «cessò il tumulto delle parole». Alle quattro del mattino seguente, «dopo il rauco stridore delle chiavi», la guardia si sporse a proferire la «frase rituale»: «La domanda di grazia è stata respinta». A quel punto, i tre giovani si apprestarono a morire da buoni cristiani.
Nel gelido mattino del 15 dicembre, durante il breve viaggio sino al poligono di tiro del Martinetto, un’atmosfera surreale sembrava avvolgere vittime e carnefici. «Il veicolo – riferirà padre Ruggero – sobbalza per le vie assonnate della città. L’aria è fredda. L’alba lontana, a malgrado dell’ora». Un brigadiere offre sigarette ai tre partigiani. «Accettano. Ringraziano».
Giunti al poligono, Testa è legato allo schienale della sedia di sinistra, Berta al centro, Attardi a destra. Nessuno parla. «Le dita della mano stringono convulse la piccola croce che i padri hanno loro regalato. È l’attimo che risolve la vita nell’eternità». Di lì a dieci giorni sarebbe stato Natale, l’ultimo Natale di guerra.
«Saluti e baci per sempre»
Da un cassetto della credenza, Anna Caterina trae una lettera piegata in quattro: gliela indirizzò Alessandro, la notte fra il 14 e il 15 dicembre. Le parole scarne e asciutte lasciano trasparire una sorta d’innato ritegno, ben congeniale all’animo di un contadino piemontese, chiuso nel pudore dei propri sentimenti. «Cara sorella, mi dispiace darti questa brutta notizia – scrisse il giovane con grafia incerta – perché sono obbligato, vado alla fucilazione questa mattina. Saluti e baci per sempre, il tuo fratello Alessandro». In calce aggiunse: «Mi raccomando di tutto quello che ti avevo detto prima, delle scarpe mie, del mio orologio da polso e della altra roba».
Nel cassetto, oltre alla stella garibaldina a cinque punte, Anna Caterina custodisce un piccolo crocifisso. A toccarlo si accappona la pelle. È quello che il fratello stringeva in pugno quando fu raggiunto dalla scarica del plotone d’esecuzione.
Alessandro Testa riposa a Settimo Torinese, nel sacrario dei caduti in guerra. Come ogni anno, sarà commemorato la mattina del 25 aprile assieme agli altri partigiani che persero la vita durante i venti mesi della lotta di liberazione.
Edicola digitale
I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.