AGGIORNAMENTI
Cerca
Pagine di Storia
26 Novembre 2023 - 01:01

A Torino le prime figure animate compaiono alla fine del 1896, grazie ad una serata organizzata da un rappresentante esclusivo dei fratelli parigini Auguste e Louis Lumière, inventori qualche anno prima del proiettore cinematografico e primi cineasti.
In città il successo è immediato, la gente ne parla, discute, frequenta con curiosità le rappresentazioni che vengono ripetutamente programmate.
È nel clima effervescente di quegli anni a cavallo del secolo, che a Torino, oltre che in pochi altri luoghi italiani, si comincia a pensare a dar vita a una seria e regolare produzione di film.
Grazie allo spirito di avventura e al coraggio imprenditoriale dei primi pionieri, allettati dal facile guadagno, dagli incontri galanti che esso regala ma anche dal fascino di uno stile di vita che contrasta con il lavoro in fabbrica o in ufficio, nel volgere di un decennio il capoluogo subalpino assume lo status di capitale cinematografica del regno.
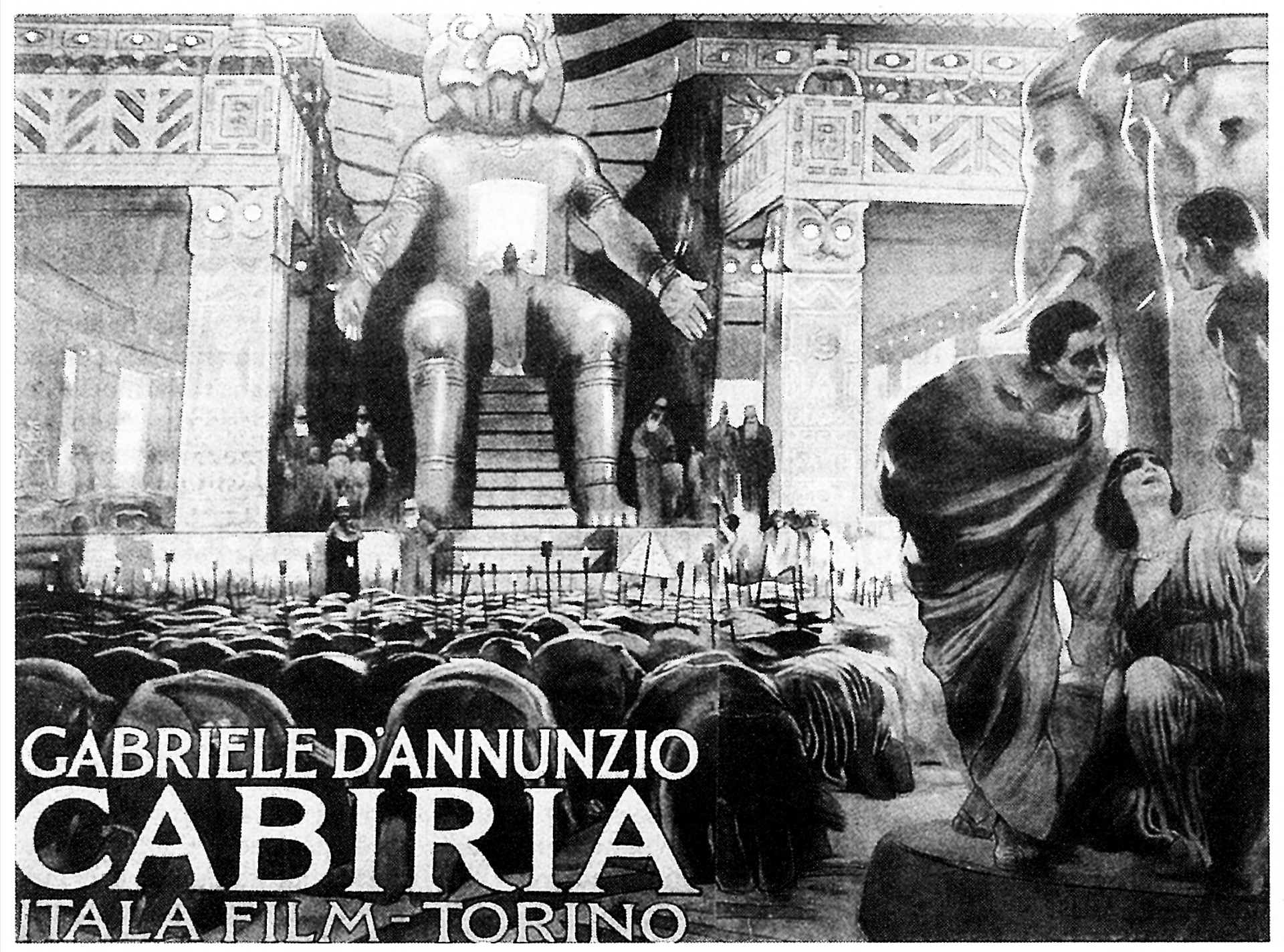
Le prime cineprese in Val d’Ala.
A beneficiare di questi effetti non è soltanto la città, ma ben presto anche le realtà periferiche ne sono toccate e anche i pittoreschi paesaggi della Val d’Ala ne sono gradevolmente coinvolti. E nel corso dell’ultimo secolo, più volte Balme sarà scelto quale luogo idoneo a far da scenario a opere cinematografiche o, spesso, a spezzoni importanti e significativi di esse.
Fin dal 10 dicembre 1909 la prima macchina da presa appare sotto la Bessanese.
Gli attori, gli operatori e il regista Carlo Alberto Lolli dell’Aquila Film, fondata a Torino due anni prima da Camillo Ottolenghi, giungono a Balme per girare un film (forse Il figlio della montagna). Non ne abbiamo ulteriori notizie, ma già nel 1916 una nuova troupe, questa volta di una certa rilevanza, risale la valle per ricreare gli esterni sardi del film Cenere, dall’omonimo romanzo di Grazia Deledda, con Eleonora Duse interprete del suo primo ed unico film, per la regia di Febo Mari.
Come ricorda Piero Crivellaro («Notiziario dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema» n. 64, 2000) «i veri esterni del film non furono girati in Versilia e in Liguria, come fior di storici ancora scrivono, ma nelle valli di Lanzo presso Torino.
Spedire la troupe in Sardegna sarebbe stato molto più costoso per l’o-culato Ambrosio, senza contare il rischio di essere colati a picco da un siluro. Cosicché domenica 16 luglio la Duse si trasferisce a Torino, dove prende alloggio dapprima al Palace Hotel. Nella seconda parte del soggiorno torinese alloggerà al Grand Hotel Europe in Piazza Castello, angolo via Roma, scomparso in seguito alla ristrutturazione del centro di Torino realizzata dal fascismo all’inizio degli anni Trenta.
Gli interni vennero girati nei nuovi (dal 1914) stabilimenti Ambrosio, che sorgevano di là della Dora in Borgo Rossini, tra le vie Mantova, Catania e Padova. Il 17 luglio la Duse scrive alla figlia: “Il mattino c’è stata la presentazione di tutto il personale, 204 persone lavorano nella mia film... Mi sembra di sognare”».
Gli esterni «sardi» vennero invece realizzati nella seconda metà di agosto tra Ala di Stura e Balme nelle valli di Lanzo, all’epoca una delle villeggiature predilette dalla buona società torinese grazie alla contenuta distanza dalla città (una cinquan-tina di chilometri) e alla comodità della ferrovia Torino-Cirié-Lanzo, che proprio nel 1916 giunge fino a Ceres.
Nella valle che si gloria della visita di illustri alpinisti come l’infaticabile collezioni-sta di vette Coolidge, o il «poeta del Cervino» Guido Rey, la lavora-zione del film è totalmente dimenticata e della stessa Duse si traman-da una vaga memoria orale.
Si parla di un autografo lasciato sul libro degli ospiti dell’Hotel Belvedere di Balme, ma l’ambìta pagina è stata strappata. Inoltre ora sappiamo che la location è testimoniata da inconfondi-bili immagini del paesaggio della Val d’Ala rimaste in diverse sequen-ze del film.
Si riconosce in particolare la chiesetta di San Bartolomeo della frazione Cresto, un chilometro a monte di Ala di Stura, in due diversi punti: nella prima parte del film, quando la diligenza con Anania bambino percorre un tratto della polverosa strada provinciale; sul finale, durante la duplice galoppata sullo stesso tratto di strada chiuso in fondo dalla chiesetta con campanile.
Si intravede anche fugacemente l’abitato di Balme con la parrocchiale quando Anania apre la finestra di una baita. Gli attori dell’Ambrosio alloggiarono al Grand Hotel di Ala di Stura, prestigioso albergo tuttora esistente. Venne aperto nel 1910 ed era frequentato d’estate da clientela internaziona-le.
L’opera è prodotta da Arturo Ambrosio, forse il primo autentico produttore cinematografico torinese, capace di generare nel 1906 una casa produttrice, l’Anonima Ambrosio, che grazie alla capacità del titolare di scritturare troupe di primo livello, alla sua indubbia vocazione e al dinamismo dimostrato nel ricercare nuove soluzioni tecniche, acquisisce rilevanza e solidità economica.

Lo vedi come sei… lo vedi come sei… con Erminio Macario.
Benché non si tratti propriamente di un film, nel marzo del 1932, l’Istituto Luce realizza a Balme un cosiddetto cinegiornale intitolato Piemonte – Inverno. Nei pochi minuti di ripresa, si scorgono scene di autentica vita paesana e dimostrazioni sciistiche. Lo sviluppo dell’attività sportiva invernale infatti, trova nel regime fascista un vigoroso sostegno e l’organizzazione di competizioni sciistiche di gran fondo e di salto dal trampolino, caratterizzano i due decenni balmesi successivi alla conclusione della Grande Guerra. E lo scopo del cinegiornale è quello di celebrare in funzione pubblicitaria e propagandistica tale vocazione.
Due anni dopo, ed è il 1934, il nostro territorio ridiventa il luogo prescelto per girarvi un film: si tratta di Si fa così, per la regia di Adriano Giovanetti: massacrato dalla critica giornalistica, l’opera non ebbe probabilmente un gran successo. Scrive M. Gromo su «La Stampa» del 7 marzo 1934: «Come è possibile, in una sequenza che vuol descrivere una gita in automobile da Torino a San Remo, farci percorrere il ponte Umberto, portarci poi nelle valli di Lanzo, farci vedere Balme e la Bessanese, e subito dopo Bordighera? Com’è possibile non scorgere attori e comparse che talvolta fissano l’obiettivo, sorridendogli, tutti contenti di poter fare un film?»
Nel 1939, Erminio Macario, abituale villeggiante di Ceres e attore affermato all’apice della popolarità, decide di utilizzare il centro del capoluogo balmese e i massi della frana dietro al cimitero, per introdurre il suo lungometraggio, che avrà un gran successo al botteghino, Lo vedi come sei… lo vedi come sei! per la regia di Mario Mattoli. Tra i giovani sceneggiatori che collaborarono all’ideazione degli sketch comici figura anche Federico Fellini, non citato nei titoli del film.
Isa Miranda.
Neanche lo scoppio della guerra ferma l’attività cinematografica. Nel luglio 1941 vi è a Balme una nuova squadra per realizzare gli esterni del film Il vetturale del San Gottardo, ultima opera diretta dall’italiano Ivo Illuminati, protagonista del cinema muto e capo tecnico dell’Istituto Luce tra il ’28 e il ’33, e dall’attore e regista tedesco di origini ebraiche Hans Hinrich, che riesce così a sfuggire alla deportazione.

IN FOTO La sfolgorante bellezza di Isa Miranda. L’attrice bergamasca nell’ottobre 1941 girò in val d’Ala alcune scene di Documento Z3. Alla sceneggiatura di questo film partecipò, pur non comparendo nei titoli, Federico Fellini.
Il 4 ottobre dello stesso anno, «Stampa Sera» dà notizia dell’imminente arrivo nelle vicinanze di Balme di Isa Miranda, diva del momento e moglie del regista Alfredo Guarini. Intendono girare il film di spionaggio Documento Z3. Il giornalista Antonio Barretta riporta: «Le montagne di Balme sono identiche, almeno in apparenza, a quelle montenegrine: così dice Guarini; e le montagne montenegrine fanno parte integrante del film. Io non so quale episodio della drammatica vicenda debba svolgersi sulle montagne del Montenegro; comunque a Balme, prima che sullo schermo ne vedranno delle belle, tempo permettente…».
Qualche giorno dopo, sullo stesso giornale, compare tra le immagini drammatiche del fronte orientale, una bella fotografia di scena della Miranda, scattata su un ponticello balmese. («Stampa Sera», 11 ottobre 1941).
Pur non comparendo nei titoli, Federico Fellini partecipò alla sceneggiatura del film.
Il bandito con Amedeo Nazzari.
È appena finita la guerra che si torna a girare a Balme. Sotto la regia di Alberto Lattuada e la produzione di Dino De Laurentis, Anna Magnani e Amedeo Nazzari interpretano magistralmente i ruoli drammatici de Il bandito. Nazzari vincerà, come Miglior Attore Protagonista, il Nastro d’Argento, premio assegnato annualmente a partire dal 1946 dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.
Nel film recita anche l’attore Carlo Campanini, già presente nella pellicola di Macario di pochi anni prima.
I dintorni di Balme, ancora chiazzati di neve a primavera, fanno da cornice alle drammatiche scene conclusive dell’opera cinematografica. Terzo film di Alberto Lattuada, Il bandito è una vicenda dall’architettura narrativa complessa e articolata. Ricordiamo che la troupe del Bandito aveva a disposizione soltanto una cinepresa che non permetteva la registrazione del sonoro; pertanto il film viene «girato senza “colonna guida”: la sorella di Lattuada, Bianca, al suo esordio come segretaria di edizione, stenografa i dialoghi durante le riprese» (C. Camerini, Alberto Lattuada, La Nuova Italia, Firenze, 1981).
Il bandito esce in Italia nel novembre del 1946, dopo la sua prima mondiale al Festival di Cannes dove è accolto con entusiasmo da parte di una delegazione sovietica, dal poeta Paul Eluard («le film que j’ai goûté le mieux est Il bandito») e da Georges Sadoul, che afferma di rinvenire nell’opera di Lattuada «il grande merito di essere significativo d’un temperamento, d’un paese, di un’epoca, di una scuola, di uno stile nuovo».
Va ricordato che fino a quell’occasione il pubblico francese non aveva ancora avuto l’opportunità di conoscere i film del neorealismo. Il successo si espande immediatamente anche in Belgio, in Germania e in Brasile, dove Il bandito supera per incasso ogni altro film straniero nella stagione 1947-1948.
In Italia la situazione scatena reazioni negative in parte della critica e nel mondo politico per il presunto abuso «di elementi drammatici e… spettacolari non raccomandabili dal punto di vista morale». Per quanto riguarda il pubblico, l’accoglienza non appare molto differente rispetto a quanto avviene all’estero: Il bandito, costato a De Laurentis 11 milioni, prevenduto a Gualino per 18 milioni, incassa sul mercato italiano 184 milioni (quando il prezzo medio del biglietto era di 54,6 lire), risultando quarto nella classifica degli incassi dei film usciti durante la stagione 1946-47. Un grande successo commerciale che rilanciò Nazzari in un ruolo completamente nuovo, ama-ro e problematico, rige-nerandolo per una lunga ulteriore stagione.
Un manifesto del film è oggi esposto al Museo del cinema di Torino.
Gli anni recenti.
Passeranno decenni prima che si torni a parlare di cinema a Balme. L’occasione è data nel 1986 quando esce Quei giorni sul Bianco di Nazareno Marinoni, film che racconta la nascita dell’alpinismo e delle società delle Guide con la ricostruzione della ricerca di una via di salita tutta italiana alla cima del Monte Bianco. Molte scene sono state girate l’anno precedente nelle sale e nelle stanze dell’albergo Camussot e nella piazzetta del vecchio centro storico del capoluogo.
Infine nel 2008 viene realizzato il documentario Tracce sui sentieri di Balme, di Gabriella Irtino, che vince il Primo Premio Concorso «Le Alpi» al 12° Valsusafilmfest 2008.
Sempre nel 2008, l’associazione Li Barmenk testimonia con un cortometraggio intitolato La Carèima, l’antica tradizione che conclude il carnevale balmese.
Un secolo di frequentazioni cinematografiche hanno evidentemente contagiato anche i montanari.
***
Molte delle informazioni contenute in questo articolo sono tratte da: Enciclopedia del cinema in Piemonte – Museo del cinema di Torino. La nascita del cinema a Torino – Gianni Rondolino.
***
Articolo tratto dalla rivista Canavèis per gentile concessione dell’editore Baima e Ronchetti
PAGINE DI STORIA
Edicola digitale
I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.