AGGIORNAMENTI
Cerca
Cultura
21 Gennaio 2023 - 19:30

Gianni Castagneri
53 anni e tre mandati da primo cittadino (il terzo è quello in corso) alle spalle. Una vita, quella di Giovanni Battista (detto Gianni) Castagneri interamente dedicata alla comunità dove è nato e cresciuto: Balme, paese che per le statistiche conta circa 110 abitanti, ma che in realtà ne ha una cinquantina.
Un paese che da duecento anni a questa parte ha scoperto la propria vocazione turistica, ma anche una serie di problemi legati alla sua posizione geografica: è infatti l’ultimo paese, venendo da Lanzo, della Val d’Ala. Per raggiungerlo bisogna risalire le ripide stradine di montagna passando per Ceres e Ala di Stura. Questo non ha di certo reso facile la vita e lo sviluppo del paese, che nel corso del tempo si spopola sempre di più.
Eppure Balme è anche stato, e lo è tutt’ora, uno strepitoso crocevia di umanità. Si tratta di un paese “giovane”, fondato solo quattrocento anni fa da una scissione dalla confinante Ala di Stura. A fondarlo fu un uomo che si chiamava esattamente come il primo cittadino: Giovanni Castagneri.
Ma i due non sono gli unici a portare questo cognome, ch qui è diffusissimo da tempo immemore. Si dice che le sue origini siano lombarde. Insomma, quattrocento anni ricchi di storia e di cultura che da quindici anni Castagneri cerca di recuperare scrivendo saggi e curando riviste come Barmes News, il periodico sulla storia locale che quest’anno compirà trent’anni.
Ed è proprio questo, il lato del Castagneri scrittore e studioso della propria comunità che vorremmo approfondire qui.
Quando nasce l’idea di scrivere saggi sulla storia del territorio?
Ho cominciato a raccogliere la documentazione verso la fine degli anni 2000 pur essendo stato da sempre appassionato di storia locale. L’ho fatto perché sentivo che la cultura locale stava pian piano scomparendo e ritenevo di avere ancora la possibilità di recuperare informazioni che altrimenti sarebbero andate perdute per sempre. Avevo del tempo a disposizione per lavorarci e così nel 2008 avevo dato alle stampe il volume “Sotto la luna. Vita agropastorale nelle alte valli”. Il libro è andato bene, la cosa mi ha appassionato e ho proseguito con altri lavori. Nel 2010, in occasione dei 400 anni dalla fondazione di Balme, pubblicai ad esempio una storia sociale del paese. Va anche detto che ho avuto facilità a trovare informazioni perché in quegli anni è stato risistemato l’archivio storico del Comune di Balme, tutt’ora a disposizione di chi vuole approfondire la storia locale.
Come mai ti sei cimentato proprio in una “storia sociale” di Balme?
Perché l’obiettivo era cercare di raccogliere nel modo più oggettivo possibile informazioni sul passato del paese, che aveva comunque quattrocento anni di storia ed era interessante approfondire.
Ci racconti in poche righe com’è nata Balme?
Balme nacque nel 1610 per scissione dal Comune di Ala di Stura. Fu sempre un piccolo paese, all’epoca era un borgo minerario e agro-pastorale. La frequentazione della montagna avveniva già dai secoli passati per usare gli alpeggi e i pascoli di alta quota. Il percorso di Balme fu spesso molto difficile per via delle condizioni climatiche e ambientali, con inverni lunghissimi che seppellivano il paese nella neve.

Una veduta di Balme in una foto d'archivio
Poi la svolta nel XIX secolo.
A metà ‘800 Balme scopre di avere una vocazione turistica e capisce che questa potrebbe essere una soluzione per l’economia. Arrivano i primi alpinisti inglesi che cercano qualcuno che possa accompagnarli in montagna. Inizialmente non trovano nessuno ma a un certo punto i montanari capiscono che accompagnarli in montagna potrebbe essere una grossa opportunità. Nasce così il mestiere di Guida Alpina. I locali conoscono la montagna perché la frequentavano da tempo, soprattutto per ragioni di contrabbando con la vicina Francia. Inizialmente si trattava di commercio a dire il vero, poi dopo il 1861 quel confine naturale diventa frontiera nazionale e quel commercio diventa contrabbando. Questa professione particolare andrà avanti per circa un secolo e consentirà alle famiglie del posto di integrare un reddito altrimenti molto eseguo.
Tra le tue ricerche ce ne sono anche alcune sull’acqua e sull’acquedotto del Pian Della Mussa. Come mai questo tema? Che importanza ha?
Sono appassionatissimo di questo tema, che era importante nel passato e ancora di più ai giorni nostri. L’approfondimento sul tema dell’acquedotto è nato un po’ per caso, perché mi ero reso conto che si stava perdendo un po’ l’attenzione sul tema, Eppure è molto importante, e di fatto aveva vincolato una parte del territorio del Pian Della Mussa che diventò fascia di rispetto per via delle sorgenti. E poi fu forse una delle più grandi, anzi forse la più grande opera realizzata nelle Valli assieme alla Ferrovia. Così mi misi a studiare attraverso fonti d’archivio questo acquedotto che dal 1922 raggiunge Torino.
Alla storia locale avete anche dedicato l’iniziativa di Barmes news, una bella rivista che è diventata uno strumento di conoscenza e di approfondimento del territorio. Che storia ha quest’iniziativa editoriale?
Barmes news nasce nel 1993, ad oggi siamo al 59esimo numero. Nacque per iniziativa di Giorgio Inaudi, lo storico locale che mi ha trasmesso la passione. Nasceva per raccogliere informazioni su Balme, e il paese ne è ricchissimo: Balme ha la fortuna di possedere un passato ricco di storie da raccontare. La rivista nacque inizialmente come rivista cartacea da distribuire per il paese. Dal 2008 me ne occupo io personalmente e la rivista viene pubblicata soprattutto online. A giugno uscirà il numro 60 che rappresenterà il trentennio di pubblicazione.
Hai parlato di Balme come di un luogo ricco di persone e storie. Secondo te cosa fa di questo luogo così piccolo un contenitore di ricchezza così grande?
Bè sicuramente il Pian della Mussa è sempre stato un punto di richiamo fin dagli albori dell’ondata turistica. In più è un Comune di fondo valle con delle montagne importanti e un paesaggio appagante, e quindi diventava ed è tutt’ora una meta interessante per chi vuole scoprire una montagna autentica e con molte caratteristiche che possono piacere a un pubblico più vasto.
Questo piccolo paese si scontra però anche col problema del decremento demografico.
Sì, soffriamo di uno spopolamento cronico che non si arresta. I dati parlano di crescita demografica ma si tratta spesso di abitanti fittizi. Gli abitanti tutto l’anno sono davvero pochi, per la carenza di servizi e per la difficoltà a raggiungere posti di lavoro e scuole. Questo rende difficile la vita alla popolazione in loco. Di fatto qui sono circa 50 persone a vivere tutto l’anno.
Tu ti sei concentrato anche sulla storia gastronomica del territorio, una storia che permette di cogliere elementi importanti della società locale. Cosa si scopre studiando il modo in cui mangiavano e mangiano i valligiani?
Ho scoperto nel corso degli anni che c’era pochissimo materiale negli archivi riguardo al cibo delle Valli di Lanzo. La preoccupazione maggiore era quella di reperire il cibo, e quindi una parte della mia ricerca l’ho dedicata proprio al tema della carenza di cibo, con tutto quello che ne consegue: un’alimentazione povera per una popolazione numerosa che voleva sfruttare ogni pezzo di territorio per riuscire a sopravvivere. Era una situazione in cui il cibo locale non era molto, e perciò sono stati importanti tutti gli alimenti che venivano da fuori, che hanno integrato il consumo di latticini.
Nel corso dei tuoi studi hai incontrato qualche aneddoto o qualche figura storica che tu ritieni significativa per il territorio?
I personaggi importanti sono diversi. Una delle figure principali è Antonio Castagneri, la prima Guida Alpina della zona. Era un giovane locale che comprese l’importanza economica dell’accompagnamento dei ricchi signori inglesi sulle vette. Scomparve a 45 anni sul Monte Bianco e non fu mai più ritrovato, diventando quasi leggendario. Un’altra figura, un Castagneri anche lui [sorride] era Angelo Castagneri che per primo cominciò a costruire una sorta di vocabolario del dialetto balmese, che io ho cercato poi di terminare. Non solo raccolse i termini dialettali ma anche tutte le disgrazie accadute nel paese dal 1700 al 1835, e questo ci ha consentito di raccogliere diverse storie descritte bene che diventano una bella base per raccogliere personaggi storici. C’è poi Quintino Castagneri, musicista locale che a metà degli anni ’70 raccolse su musicassette un insieme di musiche tradizionali locali formando un importante patrimonio archivistico musicale. Per ultimo, un altro Castagneri! E fu colui che fondò lo stabilimento Pian Della Mussa. Originario di Balme, lui viveva a Torino e a un certo punto decise di dare un contributo al suo paese di origine. Realizzò il villaggio Albaron e al tempo stesso realizzò lo stabilimento delle acque minerali.
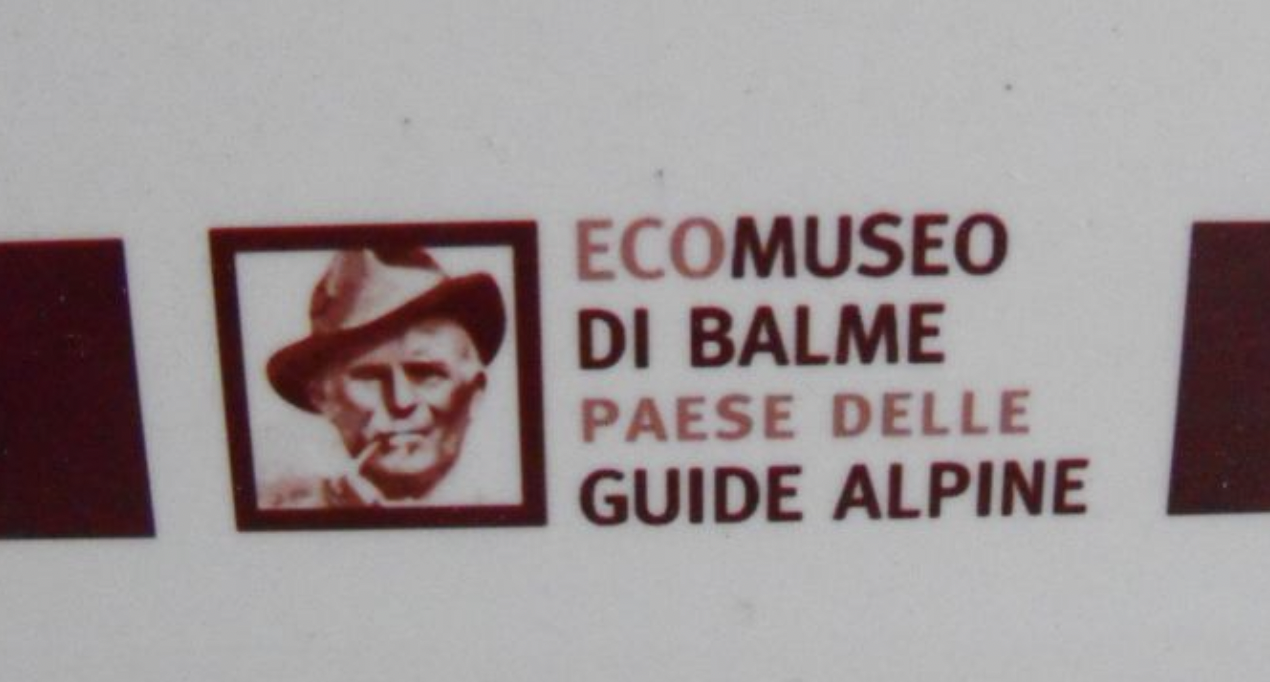
L'effigie di Antonio Castagneri sul logo dell'Ecomuseo di Balme, paese delle Guide Alpine
A questo punto la domanda è d’obbligo! Come mai così tanti Castagneri sul territorio di Balme?
Da quello che sappiamo il cognome potrebbe addirittura derivare dal bergamasco. Il paese fu fondato soprattutto da minatori bergamaschi, venuti qui ad estrarre il ferro nella nostra zona, non solo a Balme ma anche a Lemie, Usseglio, Forno Alpi Graie e così via. Lo stesso fondatore del Comune di Balme si chiamava Giovanni Castagneri, come me. Venne da Voragno e si trasferì qui dove costruì questa sorta di castello che esiste tutt’ora e si chiama Rucias. Ci sono poi altri cognomi come Martinengo, che richiama un comune lombardo che si chiama così. Va tenuto presente che queste persone venivano all'epoca da uno stato estero, e si trattava quindi di immigrati a tutti gli effetti. Comunque è probabile che cognomi come Castagneri o Martinengo non fossero locali ma provenissero da altrove.
Continuando a parlare di linguaggio e dintorni, tu ti sei occupato anche di dialetto.
Sì, il mio lavoro sul dialetto è andato avanti per circa dieci anni in cui ho cercato di raccogliere tutta la terminologia possibile. Il dialetto purtroppo va perdendosi, e così ho cercato di realizzare questo lavoro e di portarlo a termine. Quando sono stato assessore in Unione Montana mi occupavo proprio anche di dialetto e di valorizzazione del francoprovenzale. Vorrei lasciare qualcosa di una parlata o di un idioma che purtroppo andrà perdendosi.
Passiamo al Gianni Castagneri sindaco: cosa significa fare questo mestiere in un contesto così piccolo?
Intanto Balme ha una vocazione turistica e fare il sindaco in un paese turistico non è banale: sì, gli abitanti sono pochi ma come amministratori dobbiamo rispondere a tutta la frequentazione domenicale ed estiva che fa arrivare qui una popolazione temporanea ma numerosa a fronte di risorse minime. Il Comune di Balme non ha Vigili né strutture per sopportare grandi flussi. Io conosco bene queste difficoltà di gestione del territorio. In più un Comune turistico è un Comune a cui viene richiesto molto. Non basta fare fogne e acquedotti o asfaltare le strade: il Comune turistico è un Comune imprenditore che deve inventarsi iniziative che possono attrarre persone. L’attività del sindaco del piccolo Comune turistico è quindi molto imprenditoriale, ma con tutti i limiti di una struttura pubblica. E la gente si aspetta anche che il Comune faccia l’imprenditore.
Lo stabilimento dell'acqua minerale Pian della Mussa
Avevamo sollevato tempo fa il problema del grande afflusso di auto nei weekend estivi che rischia di compromettere la qualità e la salute dell’ambiente montano. Come sindaco, ma anche come studioso e giornalista, pensi che il turismo possa essere davvero il solo mezzo di sviluppo dei paesi come Balme o si dovrebbero forse ripensare i paesini come luoghi accoglienti soprattutto per chi ci vive tutto l’anno e non per chi ci viene solo per il weekend?
Credo che il turismo sia una parte dell’economia delle Valli. Certo, un paese diventa attrattivo quando è abitato. Questa è ovviamente una sfida difficilissima e complicata da portare avanti. Noi abbiamo lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali che serve dagli anni ’70 a frenare la tendenza allo spopolamento. Certo, le difficoltà di queste strutture in quota sono inevitabili, la viabilità rimane quella che è e quindi anche il trasporto è difficile. Inoltre spesso le strutture turistiche sono gestite da persone che vengono da fuori e non sempre i locali riescono ad avviare queste attività. Io credo molto anche nell’agricoltura, in un’agricoltura moderna, portata avanti da giovani, che hanno un know how non indifferente. Io poi sono appassionatissimo anche di cibo, ho gestito per dieci anni una trattoria al Pian della Mussa e quindi ritengo che anche quella sia una risorsa, e lo è ancora di più ai giorni nostri perché le persone cercano cibi di qualità di una certa origine.
Edicola digitale
I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.