L’unica opera organica che ci dia conto di quanti in Canavese abbiano scritto in piemontese è la breve raccolta Poeti dialettali canavesani approntata da
Tiziano Passera e pubblicata nell’ormai lontano 1988 dalle “Edizioni Nuova Europa–La Sentinella del Canavese” di Ivrea.
Tale testo, se si esclude la scelta di definire “dialettali” i poeti antologizzati (visto che lo strumento linguistico utilizzato nel 90% di questi testi è la lingua piemontese, cioè la koinè letteraria, e non uno dei dialetti canavesani), è comunque non solo una dignitosa base di partenza per l’esame cronologico di quanti, in Canavese o di radici canavesane, hanno scelto di esprimere, certamente più o meno bene a seconda dei casi, la loro ispirazione poetica non in italiano ma nella lingua madre (a nòstra mòda), ma anche un utile repertorio di nomi e di dati che potrebbe servire come spunto per una serie di più ampie scoperte o riscoperte.
Vediamo ora di ripercorrere la strada aperta da
Passera, riprendendo i nomi e i testi da lui segnalati e ampliando l’esposizione con le dovute integrazioni e osservazioni.
Il secolo XVIII ci offre, pur nella sua ricchezza di produzione in lingua piemontese e nei suoi dialetti, solamente un nome canavesano, cioè quello di
Francesco Antonio Tarizzo che, pur nativo probabilmente di
Favria, visse a Torino, e in torinese scrisse una sorta di poema epico, all’epoca di grande successo, sull’assedio della capitale sabauda ad opera dei gallo-ispani nel 1706. Tale opera, dal titolo di
L’Arpa discordata, giuntaci, a testimonianza del suo successo, in varie redazioni manoscritte, è stata pubblicata solo nel 1969 da
Renzo Gandolfo per il “Centro Studi Piemontesi” di Torino.
Più ampia e articolata la serie di scrittori operanti nel secolo successivo, inquadrabili, non solo per motivi cronologici ma anche per aspetti più propriamente ideologici, in momenti diversi della nostra storia letteraria. Notiamo, in via preliminare, che tranne uno o due autori tutti usarono il piemontese letterario per le loro opere e non le parlate originarie della loro terra: ciò è dovuto sia al fatto che gran parte di loro vissero e operarono più o meno a lungo a Torino sia all’essere il piemontese lingua di prestigio (della politica, della cultura, del commercio) di contro ai dialetti locali.
Nella prima metà del secolo, quindi nell’età della Restaurazione e del primo Risorgimento, scrissero l’
Armita Canavzan, pseudonimo di (presumibilmente)
Giovanni Maria Regis, originario di
Vische, autore di un esile libretto di epigrammi (
le Follie Piemontèise) stampato a Torino nel 1830, ma in due differenti edizioni: si tratta di pochi componimenti di valore molto scarso, se si eccettua qualche vivace rappresentazione quotidiana e qualche simpatica battuta scherzosa.
Di ben altro spessore l’opera di uno scrittore che si firmava con uno pseudonimo. Il
Solitari dla val ’d Breuss (o più semplicemente Solitari ’d Breuss o ancora SDB), al secolo
Giuseppe Ellena, avvocato torinese (anche per lui pochissime sono le notizie biografiche certe) ma di radici canavesane, come dimostrano non solo il suo nom de plume ma anche l’attenzione da lui riservata in parecchie sue opere ad argomenti canavesani. Collaboratore del Parnas Piemonteis, una raccolta annuale di mediocri scrittori in piemontese uscita a Torino dal 1831 al 1849, il
Solitari si eleva sugli altri scrittori di questo ambiente per una scelta coraggiosa e anticipatrice dei tempi: la decisone cioè di usare la lingua piemontese non solo per la poesia (come era abitudine già da molto tempo) ma anche per la prosa. Una prosa che usciva dagli ambiti consueti (il teatro, principalmente) per andare a toccare argomenti di storia, di geografia, di arte, di economia, di cui i suoi contributi al Parnas sono una testimonianza eccellente. Ricordiamo le prose relative all’abbazia di Fruttuaria o alla Valchiusella o ancora quella che descrive il corso dell’Orco (l’Eva d’òr). Il
Solitari è noto anche per alcune opere di carattere moralistico e di costume, quale il
Galateo piemontèis (Torino, 1834).
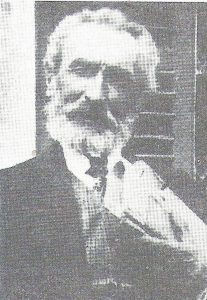 Corzat Vignòt
Corzat Vignòt
Nella seconda metà del secolo, e quindi dopo l’Unità e il passaggio della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma, con la conseguente perdita di prestigio sia della città sia della sua lingua, troviamo parecchi nomi, più o meno noti.
Fulberto Alarni, pseudonimo di
Alberto Arnulfi, nacque nel 1849 a Torino, ma di famiglia originaria di
Valperga. Orfano di madre fin da bambino, dovette seguire il padre (generale dei carabinieri e poi deputato) in varie parti d’Italia. Per tali motivi non poté seguire studi regolari e finì per impiegarsi, appena ventenne, presso la “Società Reale di Assicurazione”, per conto della quale dovette nel 1884 trasferirsi a Roma, dove morì nel 1889 (o nel 1888: le fonti sono in disaccordo sulla data) assistito dallo scrittore piemontese di teatro
Eraldo Baretti. Tra le sue opere ricordiamo la commedia
Drolarìe, rappresentata ancora oggi a testimonianza della sua vitalità, e i
Sonetti e poesie varie in vernacolo piemontese, editi postumi (come anche la commedia) a Torino nel 1926, mentre la sua prima raccolta (
Sangh bleu) è del 1876. I suoi componimenti, per lo più di tono quotidiano e spesso malinconicamente scherzoso, anticipano in alcuni loro quadretti descrittivi le atmosfere del
Nino Costa degli inizi della sua carriera poetica. Ricordiamo, nella sua produzione, tutta rigorosamente in piemontese letterario, pochi sonetti che presentano una coloritura linguistica canavesana e un altro, Roma e
’l Canavèis, scritto durante il soggiorno romano, soffuso di ammirazione per la capitale e di malinconia per la sua terra.
Di
Domenico Vugliano (di
Vestignè, 1840–1917), maestro elementare e poi segretario comunale, possiamo solamente dire che fu poeta d’occasione, autore di versi mai raccolti in volume, ma stampati su fogli volanti e diffusi tra i partecipanti a pranzi o ad altre ricorrenze per le quali le poesie erano appunto composte.
Nome più noto fu quello di
Giuseppe Riva (Ivrea, 1834–1916), avvocato, appassionato oltre che di poesia anche di musica, pittura ed enocoltura (era proprietario di una vigna cui accudiva personalmente); fu anch’egli autore principalmente di versi d’occasione, stampati in gran parte nel 1922 nel volume (ristampato poi nel 1977)
Canaveuj, ad opera del figlio Piero e con la presentazione dell’insigne giurista Francesco Ruffini.
Ben diversa, invece, la figura e la personalità di
Luigi Valsoano, nato a
Pont Canavese nel 1862 e morto a Torino nel 1906, dopo una vita durissima di lavoro e di emigrazione (visse a lungo in Belgio e in Svizzera). La sua opera, riscoperta grazie alle cure di
Tavo Burat che ne ha dato notizia nei tardi anni Ottanta del secolo scorso, consiste nel libro di poesie
Fior dël pavé (Torino, 1904; ristampato nel 2006), uscito però già l’anno precedente in una prima edizione dal titolo di
Margrite e gratacuj. Sono versi autobiografici (i primi sono del 1892) di carattere politicamente impegnato, anarco-socialisteggianti, anche se non mancano poesie d’amore; anzi, proprio alle donne, alle sue compagne di lavoro
Valsoano (
novello, si parva licet, Boccaccio del primo Novecento) dedica le sue poesie, con una forte partecipazione, anche emozionale, anticipatrice della questione femminile. In molti dei suoi versi
Valsoano si dichiara apertamente “non-poeta” (
Son pa për voi ste stròfe, ò leterà,/ son nen poeta mi, l’hai nen ’d coltura;/ iv lasso ij bej giardin, lasseme ij pra/ mi amo ij fior sèmplici, ij frut aspr dla Natura; Presentassion, vv. 17–20), sentendo fortemente la distanza tra la sua produzione “
angagià” (impegnata) e quella di tono leggero e frivolo della contemporanea poesia piemontese. Scrisse in una lingua piemontese comune zeppa di italianismi, che rivela la piena adesione alla lingua parlata a quel tempo, anch’essa infarcita di termini italiani o italianizzanti.
Medico condotto (dal 1896 alla morte) in
Valchiusella fu invece
Giacomo Felice Saudino (1855–1908) di Vico, autore di una libretto di versi piemontesi (
Fior ëd montagna, Ivrea 1907; ristampato a cura del Comune di Vico e di altri Enti ed Associazioni nel 2008): è una poesia semplice, che riflette la vita di tutti i giorni, i paesaggi della sua valle, la miseria della povera gente e la fede semplice nella religione dei Padri, in una lingua piemontese letteraria che fa da contraltare alla scelta localistica (il ruegliese) del conterraneo e contemporaneo
Péder Corzat–Vignòt.
Certamente proprio Pietro Corzetto–Vignòt è da considerarsi il poeta canavesano più importante a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento. Sia per la sua scelta linguistica (scelse, firmandosi con la forma locale del suo nome, di usare la parlata del suo paese, poco comprensibile non solo ai piemontofoni, ma addirittura agli abitanti degli altri paesi della valle) sia per i temi trattati, ben lontani dalla tradizione “dialettale” del tempo, fatta o di quadretti eleganti tratti dalla realtà cittadina (la cosiddetta poesia “
birichin-a”) o di scene oleograficamente descrittive del mondo agreste e montano del Piemonte.
Nato a Rueglio nel 1850 ed ivi morto nel 1921,
Péder Corzat visse una vita, almeno nella sua prima parte, piuttosto movimentata: dopo gli studi (non conclusi) al ginnasio-liceo di Ivrea, passò a Torino e poi, con la madre ed una sorella, in Svizzera (dal ’75 all’82) e poi ancora a Livorno e a La Spezia, per tornare infine (nel 1908) al suo paese natale, dove visse fino alla morte. I suoi versi sono raccolti nel libro
Stil alpin (che comprende anche una commedia), uscito a dispense a La Spezia nel 1889 e poi ad Ivrea dall’editore Garda nel 1911 (e ristampato nel 1976). La scelta di usare la sua parlata natia, abbastanza controcorrente in quegli anni, lo obbligò anche ad elaborare una grafia (nessuno aveva mai scritto in ruegliese) che egli presenta nell’introduzione (la Teknigrafia del dialetto ruegliese) al suo volume: è una grafia molto complessa ed elaborata (al limite talora del fantasioso) e scarsamente funzionale, ma con una sua logica e coerenza, per la quale anche il famoso linguista
Gianrenzo Clivio ha parole di misurato elogio. I suoi testi sono stati riscritti, e pubblicati sulla rivista “
Musicalbrandé”, secondo la grafia normalizzata della lingua piemontese e dei suoi dialetti (cioè la grafia definita “Pacotto–Viglongo, che è in grado di riprodurre, con piccole varianti e aggiunte, tutte le forme delle diverse parlate piemontesi), dall’alladiese Giovanni Bono, di cui parleremo tra poco.
Nativo di
Cuorgnè (1839–1922),
Giovanni Oberto, pressoché sconosciuto anche ai cultori della poesia piemontese, è autore di un libretto di composizioni poetiche (
Rime Piemontesi dl’antich Frà Martin, 1915) e di altri componimenti d’occasione con lo pseudonimo di “
Magnin ’d Corgnè”. Dopo un breve soggiorno in Argentina con un fratello e le nozze con la cognata del grande capocomico e fondatore del teatro piemontese, il cuneese Giovanni Toselli, visse per qualche tempo a Roma (dove diresse la Casa editrice “Bocca”); tornò poi al paese natale, dedicandosi all’insegnamento elementare. Di idee socialiste, fondò la Società di Mutuo Soccorso di Cuorgnè, mentre le sue poesie si caratterizzano per arguzia e semplicità, ma nulla più.
Da un nome pressoché sconosciuto ad uno arcinoto, almeno per la poesia in italiano, ma riguardo al quale pochi sanno essersi cimentato anche in versi piemontesi. Si tratta di
Guido Gozzano (1883–1916), nato a Torino ma (come tutti sanno) di famiglia originaria di
Agliè, paese dove soggiornò frequentemente nella sua villa del Meleto. Tra le sue poesie figurano anche due sonetti (
Ij toton, del 1911, e
Barba, non databile) in piemontese, che altro non sono se non le traduzioni di due sonetti dell’amica poetessa
Amalia Guglielminetti (rispettivamente
Le oscure e
Catene, che figurano entrambi nel volume Le vergini folli, Torino 1907).
A Torino nacque e passò gran parte della sua vita anche un altro scrittore di famiglia canavesana,
Vittorio Actis Dato di
Rodallo di Caluso, noto nel mondo delle lettere con lo pseudonimo di
Amilcare Solferini (1870–1929). La sua vita fu alquanto travagliata: lo portò per qualche tempo emigrante in Argentina e poi nuovamente a Torino, dove fu commerciante. Fu autore di molte poesie di grande suggestione e originalità, pubblicate frequentemente sui giornali del tempo (tra cui
“’L caval ’d bronz” e “
’L Birichin”, di cui fu anche direttore) e poi in gran parte pubblicate in tre volumi:
Soris e smòrfie (1894),
Sonèt e rime (1903) e
Mentre la tèra a gira (1923), il suo capolavoro. Fu anche autore per il teatro, sia di commedie serie che di “vaudevilles”, che incontrarono sempre un buon successo presso il pubblico del tempo. Nelle sue poesie troviamo descritta la vita del tempo, attraverso la rappresentazione di personaggi tratti dalla realtà e di quadri realistici e talora crudi, senza compiacimenti e finzioni, a volte umoristici a volte polemici, ma sempre umanissimi. Specie nell’ultima raccolta, poi, fa la sua comparsa una vena di malinconia che sembra anticipare la tragica decisione presa pochi dopo dall’autore, che morì suicida.
Per concludere il periodo compreso tra la fine di un secolo e la prima metà del successivo ci restano da esaminare ancora due figure di poeti:
Francesco Carandini (1858–1946) e
don Luigi Tessitore (1863–1949).
Il primo è il famoso storico della città di
Ivrea, autore, tra le altre sue opere, di quel monumento che è
Vecchia Ivrea (1914), ancora oggi studio fondamentale sulla città. Parente alla lontana della famiglia
Giacosa (nacque infatti a
Colleretto Parella, in casa Giacosa), dopo essersi laureato in legge intraprese la carriera prefettizia, peregrinando tra Biella, Roma, Forlì, Verona e Udine, ma nel 1923 (in contrasto col regime fascista) rinunciò alla carriera e si ritirò in Canavese per dedicarsi agli amati studi storici. Anche come poeta Carandini merita di essere ricordato: una sua composizione (
Avi Marìa d’Otóber) del 1905, infatti, firmata con lo pseudonimo di “Chin ’d Parela”, oltre a tramandarci parecchi termini della parlata parellese d’allora, è soffusa di una malinconia quasi virgiliana, distaccandosi dalla poesia, in genere superficiale, caratteristica di quegli anni di inizio secolo.
Il secondo, nativo di
Montalenghe, fu sacerdote e ricoprì nel corso degli anni svariati incarichi nella diocesi di Ivrea: fu vice-parroco a Strambino, cappellano dell’ospedale di Ivrea e, soprattutto, docente di Matematica in seminario per 43 anni. Autore di parecchie pubblicazioni italiane di edificazione religiosa, i suoi versi piemontesi (scritti in piemontese comune dal 1888 fino a pochi anni prima della morte) sono stati da lui raccolti in 5 quadernetti manoscritti (conservati presso la biblioteca vescovile di Ivrea) e pubblicati integralmente solo nel 1994/95. Sono poesie che rivelano l’uomo di cultura che guarda con occhio attento la realtà di tutti i giorni, da quella concreta della vita di una città come Ivrea a quella più ampia che coinvolge il mondo esterno: abbiamo parecchie sue composizioni di satira contro idee politiche (il socialismo, il femminismo) e costumi e mode da lui non condivisi. È un peccato, poi, che siano ora introvabili le sue prediche manoscritte (1895–1901), che, secondo le indicazioni date da
Camillo Brero nella sua
Storia della letteratura piemontese, dovrebbero trovarsi anch’esse nella biblioteca vescovile di Ivrea.
Il nuovo secolo si apre con un nome di tutto rispetto, quello di
Nino Costa, citato in questa sede più per le sue origini
ciriacesi che non per la sua “canavesanità” poetica. Egli infatti, nato e morto a Torino (1886–1945), anche se in alcune sue composizioni ricordò le sue radici canavesane, oltre a quelle monferrine da parte di madre (soprattutto
Canavèis, del 1928, ma anche
Rassa nostran-a, Aque ’d Piemont, Mè piemontèis ed altre), fu il poeta “torinese” e “piemontese” per eccellenza.
Nel secolo appena trascorso abbiamo altre belle figure di poeti canavesani, di nascita o di radici.
Giovanni Drovetti (1879–1958), di
(anche se nato a Sesto San Giovanni, vicino a Milano), autore di molte opere varie in italiano e di alcune poesie piemontesi.
Enea Riccardino (1903–1967), medico e poeta di
Chiaverano, persona di grandissima umanità e autore di versi piemontesi senza molte pretese (anche se pieni di buon senso), riuniti nel libretto
’L viage ’nt la lun-a–Còse dl’àutr mond (Ivrea, 1961), e di altre composizioni sparse.
Giovanni Bono (1901–1982), di origini
alladiesi, fu collaboratore delle riviste
“Ij Brandé, giornal ëd poesìa piemontèisa”, fondata da Pinin Pacòt, e “
Musicalbrandé”, fondata e diretta da
Alfredo Nicola, sulla quale pubblicò la versione in grafia normalizzata delle poesie di Péder Corzat–Vignòt. Autore di poesie tra le migliori del Novecento letterario piemontese, molte delle quali stampate nel volume
Rime care, Rime dosse (Torino, 1979), tra i suoi componimenti segnaliamo una testimonianza del parlare di Macugnano (M
onia quacia), paese al quale è anche dedicato il sonetto in piemontese
Ël paisòt nen tut mè (Brich e ciabòt perdù. Mè mond l’é al pian:/ asfalt rumor fumeria dla sità;/ però am pias diciaré: «So ’d Macugnan». vv. 12–14 ).
Italo De Laurenti (1932–1984), nato a
Favria–Oglianico (tale la definizione del comune durante il fascismo), ma alladiese di origini e di vita. Organizzatore culturale (tenne per vari anni un corso di piemontese alla scuola media di Agliè) e riscopritore di usi e tradizioni locali, è autore di un solo libro di poesie piemontesi:
Care muraje, del 1974, che riprende nel titolo un verso di una famosissima canzone del Brofferio (
Mè ritorn).
Carlo Gallo, noto come Galucio (Rivarolo Can.se, 1908–1998), autore di teatro, musicista e attore di grande fama, autore di ben 9 commedie piemontesi ancora oggi portate con successo sulla scena sia dalla compagnia da lui fondata (la
“Companìa canavzan-a”) sia da altre compagnie, oltre che di numerose poesie che svariano dal melanconico al faceto, dal serio all’ironico, stampate in due libri (
Chicchirichinade ’d Galucio, del 1979, e
Tarabàcole–Ròbe da nen, 1986) e riprodotte in parte anche su disco e musicassetta con lettura dell’autore stesso.
Chiudiamo questo brevissimo panorama di poeti piemontesi in Canavese con alcuni nomi di scrittori contemporanei, alcuni ancora viventi altri purtroppo no, quali
Francesco Sulliotti di Ivrea,
Lucia Broglio Germanetti di Borgofranco,
Remo Bertodatti di San Giorgio,
Rita Giacomino di Sale–Castelnuovo,
Maria Teresa Cantamessa Andrina di Ivrea,
Giuseppe Giorgio di Ivrea,
Ada Marta Benevenuta e
Mariuccia Manzone Paglia di Rivarolo,
Elsa Oberto di Agliè,
Germana Cresto di Feletto,
Pier Luigi Franzino di Feletto ed altri ancora.
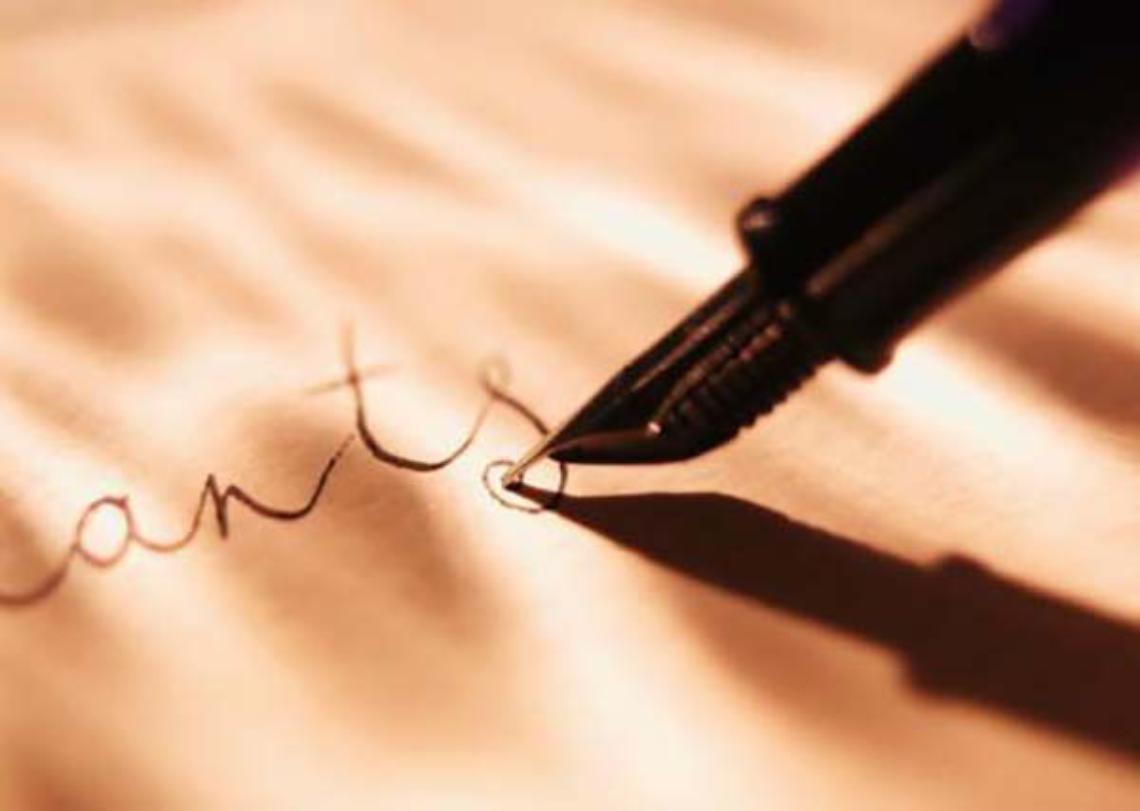
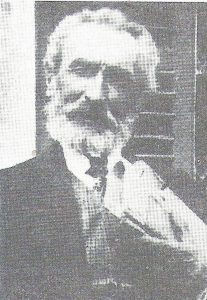 Corzat Vignòt
Corzat Vignòt