AGGIORNAMENTI
Cerca
Storia
21 Aprile 2023 - 15:10

La parola “sbirro” è diffusa nella nostra lingua da secoli. L’etimologia del vocabolo non è certa: secondo i vocabolari l’ipotesi più probabile è che derivi dal latino tardo “birrum“, il mantello rosso a cappuccio che avrebbero indossato gli antichi sbirri, a sua volta proveniente dal greco “pyrròs”, “rosso”; a partire da “birro”, “sbirro” si sarebbe formato tramite l’aggiunta del prefisso s con valore peggiorativo.
Ma si può intuire il perché di questa piega spregiativa: questi sbirri dei tempi passati spesso non erano che il braccio armato del signorotto di turno, che li impiegava per imporre il suo potere sul popolo inerme. Niente a che vedere con corpi armati al servizio della giustizia.
Quindi, paradossalmente, in questa parola così scapigliata e ribelle, ritroviamo il retaggio di una memoria storica secolare, il maturo ricordo di un’oppressione bruciante di armigeri dalla casacca di colore che certe guardie del medioevo e del rinascimento indossavano come uniforme.
Alcuni studiosi avanzano anche un’altra ipotesi, cioè che possa trattarsi di una variante di “sgherro”, parola che già anticamente designava l’uomo al servizio di un potente, dai modi violenti e intimidatori, alla stregua dei bravi e dei sicari . Nel medioevo avevamo anche il berroviere o birroviere, dal provenzale berrovier, dal francese antico berruier, forse «uomo, soldato della regione francese del Berry.
Questi Birri erano così chiamati nei sec. 13° e 14° gli uomini armati che venivano assegnati ai priori per l’esecuzione degli ordini, o che i podestà, i bargelli, i capitani del popolo portavano con sé quando si recavano a esercitare la loro carica in un comune: e chiamaronsi Priori dell’Arti ... e furono loro dati sei famigli e sei berrovieri (Compagni). L’incremento che ebbe l’impiego di berrovieri mercenari nelle guerre comunali del Nord Italia fece si che questi combattenti, di propria volontà e non più su richiesta, prendessero armi e bagagli per accorrere, anche non voluti, ad ogni sentore di guerra in vista di ricchi bottini e facili guadagni, operando quasi ai margini della legalità.
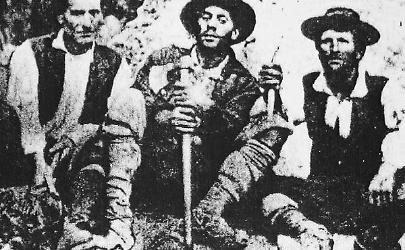
Nel Canavese del XIII secolo venne istituita la lega contro il brigantaggio, infatti, l’endemico stato di guerriglia fra i signori locali nonché i frequenti attriti fra le maggiori città dell’Italia nordoccidentale, fra Ivrea e Vercelli, Pavia e Milano, Vercelli e Novara, determinarono uno stato di grave tensione, in cui le alleanze fra tali piccole e medie potenze si alternavano in un crescente e pericoloso gioco d’interessi e di rivalità.
In questa situazione s’inquadra la costituzione della “grande lega del Canavese”, della quale facevano parte non solo i conti delle varie casate ma anche il forte comune d’Ivrea, suggellata dalla “Carta Concordiae” del 1213.
L’alleanza fra canavesani ed eporediesi doveva dissuadere la politica espansionistica intrapresa dal Marchese del Monferrato e sostenuta da Vercelli, ma, già nel 1231, le rinate rivalità fra i conti ed il comune d’Ivrea, in un primo tempo neutralizzate con un nuovo accordo del 1229, compromisero irrimediabilmente il futuro della lega.
La comunità di Favria, posta sotto il controllo dei Monferrato, non era certamente in grado di vivere in prima persona queste controversie. Tuttavia almeno un atto del consortile deve aver interessato anche il borgo favriese.
Si tratta della convenzione dell’11 marzo 1263, stipulata da Vercelli ed il Marchese del Monferrato con i conti del Canavese, per l'”estirpamento dei berrovieri e dei ladri”. (A.Bertolotti, “Convenzioni e statuti nell’estirpamento dei berrovieri e dei ladri dal Monferrato, Canavese, vercellese e Pavese nei secoli XIII e XIV”, in “Miscellanea di storia italiana”, tomo XII, Torino, 1871, pp. 735.-761 e G. Frola, “Classificazione degli statuti”, B.S.B.S., Torino, 1905, p. 144).
Infatti, il fenomeno del brigantaggio, causato dall’imperversare delle guerre e dalle sopraffazioni dei signori, aveva assunto proporzioni tali da richiedere interventi straordinari per la sicurezza delle strade e la difesa dei piccoli borghi rurali come la costruzione di recinti e luoghi fortificati. Ricetti, per racchiudere i raccolti.
Edicola digitale
I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.