AGGIORNAMENTI
Cerca
Pagine di storia
12 Marzo 2023 - 16:04

Nel passaggio tra feudo nel secolo XIII e poi nel comune nel secolo XIV l’organizzazione del lavoro e il rapporto tra campagna e città cambiarono sensibilmente, quasi si ribaltarono.
Se prima era la campagna a reggere il sistema economico, con i contadini che lavoravano a vita per la corte, del re o del nobile locale, fornendo cibi e poco altro, con il sorgere dei comuni, l’industria, il commercio e la pubblica amministrazione diventarono i campi principali della produzione della ricchezza.

La condizione e la ricchezza dei contadini non era cambiata di molto. il ricavato del loro lavoro era sempre sulla soglia della sussistenza, molto spesso al di sotto.
Il reddito annuale del contado fiorentino si aggirava attorno a 70-80 fiorini per famiglia, con il lavoro di almeno tre persone, il che ci porta a un ricavato mensile di 6-7 fiorini.
Il fiorino però era un’unità salariale. Nei rapporti commerciali e nei prezzi al dettaglio si parlava di lire, soldi o denari. Un fiorino valeva circa 30 soldi. Il salario mensile di una famiglia, composta da chi lavorava e da chi non poteva, era di circa 180 soldi al mese, 6 al giorno. Allora il costo di un paio di scarpe era di 12 soldi, circa due giorni di lavoro. Inoltre, il contadino doveva pagare di tasca sua attrezzi e sementi. Nella maggioranza dei casi, una famiglia non riusciva ad andare avanti solo col lavoro dei campi. Ecco perché le donne dovevano spesso cercare lavoro in città come domestiche, balie o filatrici.
La paga delle domestiche era bassissima, 3 fiorini l’anno, ma la famiglia di origine era sgravata dalle spese di mantenimento. Una balia arrivava fino a 9 fiorini all’anno, vista la responsabilità che il lavoro richiedeva. La maggior parte delle donne che arrivavano a Firenze però cercavano lavoro nel tessile.

Nella prima metà del XIV secolo Firenze contava circa 100.000 abitanti ed era una delle città più grandi del centro Italia, nello stesso periodo Roma arrivava a poco più di 40.000. Di questi, secondo gli studiosi dei registri e i dati di archivio, più di 30.000 erano legati all’industria manifatturiera e al suo indotto. Per passare dalla lana grezza al prodotto finito c’era una catena di 15 passaggi.
Filatrici, orditrici, tessitrici, pettinatrici, battitori, conciatori, tintori. Fu in quell’epoca, infatti, che nei comuni più attivi, si svilupparono le Gilde che raggruppavano i vari tipi di lavoratori. Questa differenziazione e specializzazione delle varie fasi lavorative, fece sì che difficilmente un singolo operaio tessile potesse conservare una sua autonomia e aprire una propria bottega tessile. La maggior parte, dunque, erano dipendenti di opifici.
Gli operai stipulavano un contratto a termine e dovevano rispettarlo per la scadenza e la qualità del lavoro. Se lasciavano il lavoro prima della fine del contratto, dovevano pagare una multa di 10 lire, circa 200 soldi, cifra enorme allora per un operaio. La giornata iniziava col rintocco della campana del podestà, che d’estate suonava al sorgere del sole. D’inverno invece il lavoro iniziava ancora col buio.
La fine era sempre al tramonto, con un breve intervallo a mezzogiorno per il pasto. Il lavoro notturno era proibito, sia per la scarsa qualità dei lavori effettuati a lume di candela, sia per la paura di incendi. La paga era in media 8 soldi al giorno, ma in un anno, tolte le domeniche e le feste, si arrivava a 230 giorni di lavoro e si veniva pagati solo se si lavorava. La paga annuale era quindi di circa 1840 soldi, divisi per 365, con un guadagno reale di circa 5 soldi al giorno. Il costo del vitto era di 3 o 4 soldi al giorno.
Le famiglie erano sempre a rischio fame o sopravvivenza. Un altro problema era che il salario degli operai era pagato in quattrini, piccole monete di rame, con un cambio sfavorevole rispetto al soldo o al fiorino. Questo rendeva ancora più debole il potere d’acquisto delle famiglie più povere.
A colpire ulteriormente il salario dell’operaio concorreva il sistema di multe ed ammende in vigore negli opifici. Se un lavoro non era ben fatto, si infliggevano multe crescenti. La prima volta che una filatura veniva trovata difettosa, la multa era un soldo. Se lo stesso operaio commetteva lo stesso errore, si saliva a due lire, 40 soldi. Un tessitore, livello più raffinato di lavorazione, che non correggeva i punti imperfetti subiva una multa di 5 lire, ben due settimane di salario di allora. Oltre a carenze sul lavoro, le multe venivano inflitte per disubbidienza, mancanza di rispetto, turpiloquio. E, se non si pagava nei tempi, scattavano le more.
Le multe venivano inflitte multe? Ogni opificio aveva un sistema di sorveglianza, comandato da un “ufficiale forestiere”, così chiamato perché veniva da un’altra città. Doveva avere una formazione giuridica, erano spesso erano notai, ed erano i garanti della disciplina interna all’opificio. Lo stipendio di un ufficiale forestiere era di 600 lire all’anno, e aveva alle sue dipendenze, a libro paga, una rete di informatori e sorveglianti, che prendevano il 25% di tutte le multe che infliggevano. Il popolo grasso Fin qui la vita dei contadini e degli operai.
Ma il cosiddetto “popolo grasso”, i benestanti, quanto guadagnavano? Non è facile quantificarlo, perché il XIV secolo è stata un’epoca di vorticosi giri di denaro, con ricchezze che sorgevano e svanivano nel giro di pochi mesi. Ma dai registri delle casate, abbiamo il dato delle spese annuali. In media una famiglia benestante di Firenze spendeva circa 1200 lire all’anno, più di 60 soldi al giorno, pensate che un operaio ne incassava in media 5 al giorno.
Per renderci conto del giro di denaro vi trascrivo quanto fli storici hanno trovato al riguardo di una delle aziende più ricche della Firenze del XIV secolo: la compagnia dei Bardi. La chiusura del bilancio dell’1 luglio 1318 segna un giro di affari di 873.638 fiorini d’oro, con cento dipendenti salariati distribuiti in 25 filiali, 12 in Italia, 4 nel Levante-Medio Oriente, 9 tra Francia, Spagna, Paesi Bassi, Inghilterra e Tunisi, con stipendi che andavano da 5-7 fiorini all’anno per gli apprendisti ai 200 dei direttori delle filiali maggiori e ai 300 dei direttori centrali della sede di Firenze. Se pensiamo che i Bardi erano solo una delle grandi famiglie-compagnie che operavano a Firenze, possiamo renderci conto della ricchezza della città.
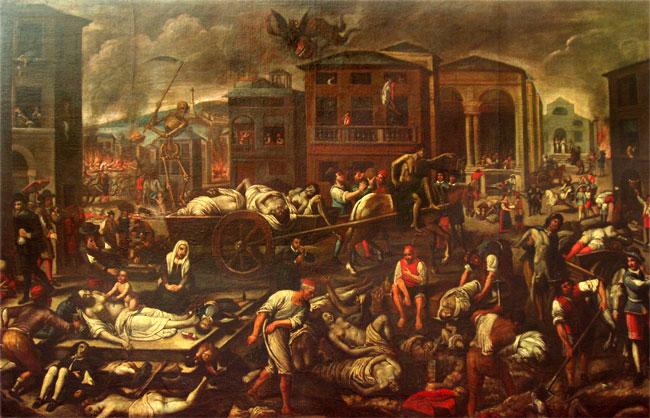
Se l’industria tessile era quella che occupava il maggior numero di operai, quella edile, anch’essa molto forte, offriva salari migliori. Un capomastro chiedeva, ed otteneva, 30 soldi netti al giorno, sei volte più di un tessile, e gli operai edili potevano chiedere 20 soldi al giorno. A differenza del tessile, però, va detto che il lavoro non era garantito e potevano esistere periodi di disoccupazione. Facendo però un paragone, un operaio edile per arrivare a 1840 soldi doveva lavorare 92 giorni invece di 230. Un altro settore che assicurava un tenore di vita decoroso erano le botteghe artigianali, soprattutto quelle dei fabbri e dei negozianti al dettaglio. Pure in assenza di dati univoci, si può dire che il reddito medio di un bottegaio era tra le 5 e le 10 volte superiore a quello di un operaio (tra i 25 e i 50 soldi al giorno).
Tra i più ricchi della città, c’erano i notai e i medici, più dei sacerdoti e dei medici. Il notaio, ossia l’ufficiale giudiziario che certificava la legalità di atti e transazioni, era indispensabile in una civiltà fondata sul commercio e sulle speculazioni. Per la stesura di un atto, il costo era di un fiorino circa 30 soldi. Se poi il notaio era alle dipendenze del comune, il salario annuo andava da 300 lire quando era appena assunto, fino a 800, dopo qualche anno. Ancora più dei notai, i medici incassavano parcelle da favola. È vero che la medicina era ancora legata alla tradizione di Ippocrate e che il medico si limitava spesso a dare consigli di filosofia naturale o di ordine igienico-dietetico, ma quei consigli erano pagati cari. Un consulto a domicilio costava un fiorino d’oro.
I medici più famosi, con poche visite o consulti prolungati, potevano accumulare cifre pari all’affitto dei palazzi nobiliari, che arrivavano tra i 40 e i 50 fiorini d’oro all’anno. Come per i notai, poi, se il medico era dipendente del comune, oltre alle visite private, poteva contare su uno stipendio variabile tra le 50 e le 120 lire all’anno.
Insomma, nella Firenze di quegli anni non si riconosceva il valore del lavoro, solo i “grandi professionisti”, gli uomini d’affari senza scrupoli e capaci di rischiare, e tutti coloro che riuscivano a far fruttare il denaro, emergevano. Fra questi in particolare gli imprenditori che, sfruttando il lavoro di operai e disperati, cui offrivano un minimo per sopravvivenza, guadagnavano invece grandi cifre per sé.
Edicola digitale
I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.