AGGIORNAMENTI
Cerca
Attualità
13 Novembre 2025 - 09:23

A Torino la raccolta in cassonetti degli abiti usati - pensata per unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e solidarietà - sta diventando un problema di decoro e sicurezza urbana. Lo ha denunciato in Consiglio Comunale la consigliera Silvia Damilano (Gruppo Torino Bellissima), autrice dell’interpellanza “I cassonetti per la raccolta degli abiti usati a Torino”.
Damilano ha ricordato come tale raccolta “costituisca un servizio con valenza ambientale, sociale e solidale, permettendo il riuso di capi che altrimenti finirebbero in discarica”. Tuttavia, ha segnalato criticità sempre più diffuse, come quella di piazza Rebaudengo, dove cassonetti depredati e abiti abbandonati a terra rappresentano ormai una scena quotidiana. Come modello alternativo, la consigliera ha citato “Abito”, progetto promosso dall’ODV Società di San Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale di Torino, che raccoglie, seleziona e redistribuisce gratuitamente capi usati attraverso un emporio sociale. “Un modello che funziona - ha spiegato - perché unisce dignità, sostenibilità e inclusione. Sarebbe auspicabile replicarlo nelle aree più colpite da vandalismi e svuotamenti abusivi”.
A rispondere è stata l’assessora alle politiche per l’ambiente e alla transizione ecologica Chiara Foglietta ricordando che la raccolta differenziata dei tessili è obbligatoria in tutta l’Unione Europea dal 1° gennaio 2025 in base alla Direttiva UE 2025/18/92, e che l’Italia ha anticipato tale misura con il D.Lgs. 116/2020, in vigore dal 2022. “Torino rispetta pienamente questi obblighi - ha precisato - con 409 cassonetti dislocati sul territorio e svuotamento settimanale”. Le criticità, ha spiegato, derivano in larga parte da “cernite abusive operate da ignoti”, un fenomeno in crescita che provoca la dispersione degli abiti a terra. Le cooperative affidatarie del servizio intervengono nei giorni di svuotamento, mentre la società Amiat si occupa delle altre giornate. I cassonetti - in lamiera e acciaio, dotati di dispositivi antintrusione e lucchetti – “non garantiscono però una protezione assoluta da atti vandalici”. Foglietta ha infine ricordato il progetto europeo Climaborough, che il Comune sta portando avanti fino al 2025 per sensibilizzare i cittadini al riuso dei tessili e promuovere pratiche di economia circolare. I risultati, attesi per l’inizio del 2026, “potranno fornire indicazioni utili per migliorare logistica e raccolta”.
Ma dove finiscono gli abiti? Per approfondire il destino degli abiti raccolti - e spesso purtroppo depredati - abbiamo chiesto un parere ad Andrea Fluttero, presidente di UNIRAU (Unione Imprese Raccolta, Riuso e Riciclo Abbigliamento Usato), con sede a Torino. L’associazione, evoluzione del consorzio CONAU (nato nel 2008), rappresenta le aziende e le cooperative che operano nella filiera della raccolta e valorizzazione dei rifiuti tessili.
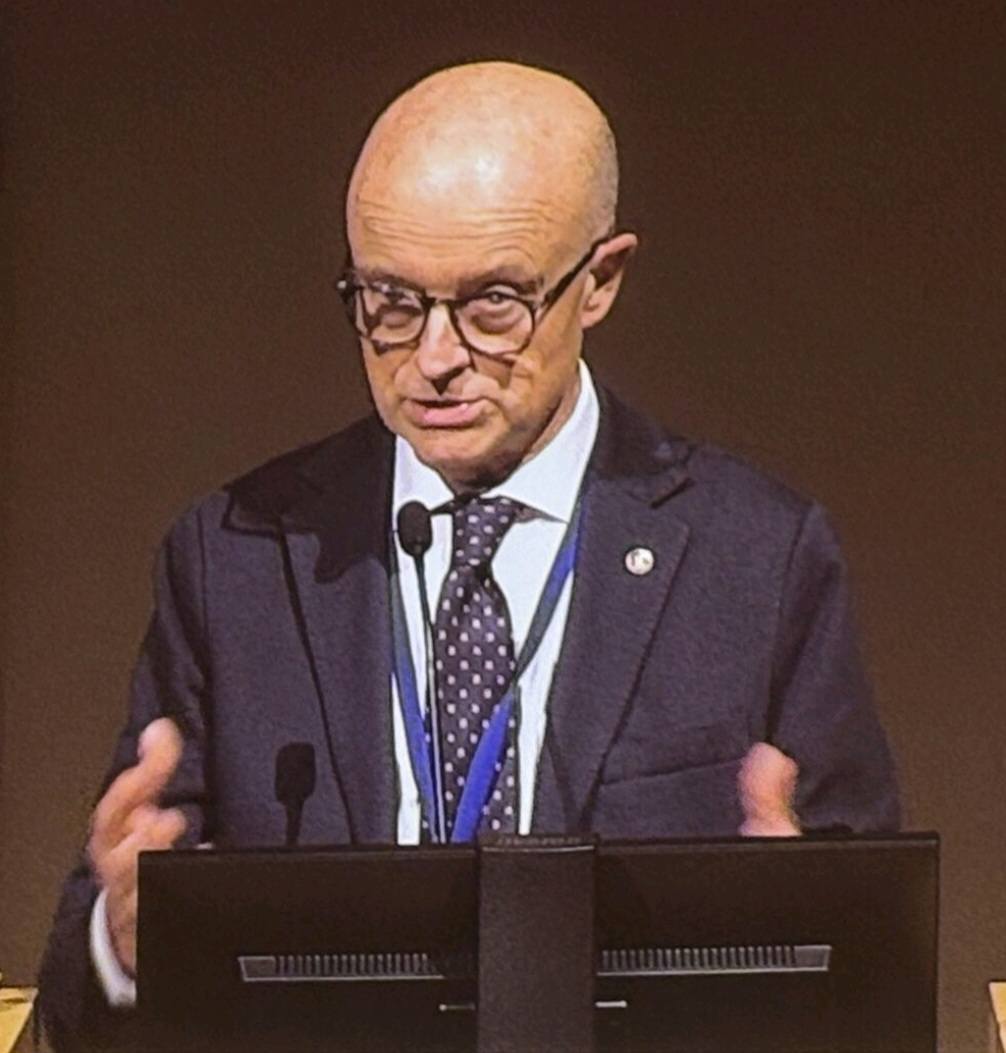
Presidente Fluttero, partiamo dal caso torinese: l’interpellanza di Silvia Damilano ha evidenziato un problema di degrado urbano e vandalismo dei cassonetti. Dal suo punto di vista, si tratta di episodi isolati o di un sintomo strutturale del sistema di raccolta?
“E’ un sintomo strutturale della presenza di una organizzazione dedita al furto dei rifiuti tessili di maggiore qualità presenti nei cassonetti che crea degrado ed arreca danno alla cooperativa che presiedo, che viene pagata per il proprio lavoro con il materiale raccolto. Abbiamo sporto denuncia ai Carabinieri e sappiamo che è stato aperto un fascicolo. Questi furti non sono determinati dal bisogno di vestiti per uso personale in quanto in città sono presenti molti enti caritatevoli che hanno grandi quantità di vestiti da donare, ma dalla presenza di una vera e propriaorganizzazione criminale che ruba e vende in nero e disattende totalmente le leggi ambientali per la cessazione della qualifica di rifiuti tessili alimentando filiere illegali e non tracciate”.
Lei ha sottolineato più volte che le raccolte differenziate non sono donazioni ma flussi di materiali da valorizzare. Può spiegare ai lettori qual è la differenza e perché è importante comprenderla per evitare fraintendimenti etici o mediatici?
“Tutte le raccolte differenziate sono finalizzate a riuso o riciclo sia per ridurre lo smaltimento in discarica o il recupero energetico, che per ricavare valore che serve a contenere i costi del servizio alla collettività. Le donazioni sono regolate dall’art. 14 della legge 116/2016 che chiarisce che la donazione deve essere effettuata presso la sede dell’ente che si occuperà di donare. In quel caso il materiale donato è esentato dal rispetto della normativa rifiuti. Di conseguenza, quanto conferito nei cassonetti stradali è ovviamente classificato come rifiuto differenziato finalizzato alla valorizzazione”.
Spesso si parla in modo impreciso delle esportazioni di abiti usati. Ci può chiarire cosa accade realmente ai capi selezionati in Italia e venduti all’estero, e perché non si può parlare di “smaltimento”?
“Queste raccolte differenziate vengono acquistate dalle imprese della selezione che possono essere basate in Italia, in Europa o fuori dall’Europa. Queste imprese fanno cessare la qualifica di rifiuto a quanto acquistato come previsto dal DM 5 febbraio 98 tramite selezione ed igienizzazione. Vengono separati i prodotti riusabili da quelli non riusabili. Dai primi si ottiene valore tramite la vendita sui mercati globali dell’usato e del Vintage. Dai secondi si evita per quanto possibile lo smaltimento che è molto costoso tramite la trasformazione in strofinacci per la pulizia, la sfilacciatura per ottenere imbottiture o materiali fonoassorbenti. Rimane mediamente dal 5% al 10% di scarto non recuperabile che va a smaltimento. Le esportazioni legali possono essere quindi composte di usato selezionato in Italia oppure di raccolte da selezionare comprate da selezionatori basati fuori Italia o fuori Europa. Esiste come purtroppo in ogni settore anche l’illegalità che deve essere contrastata e che esporta raccolte illegali generate da furti oppure rifiuti da smaltire sottocosto”.
Uno dei casi più citati è quello della Tunisia, dove vengono inviati i cosiddetti “rifiuti originali”, ovvero non ancora selezionati. Come funziona in realtà questa filiera e qual è il ruolo delle aziende tunisine?
“In Tunisia vi è una forte e storica presenza di aziende della selezione che comprano in Italia, in Europa, in UK ed in Canada raccolte differenziate da selezionare per fornire i loro clienti di usato. Il settore è detto della “friperie” ed è molto apprezzato in Tunisia perché genera migliaia di posti di lavoro in special modo femminile, sia nella selezione che nella filiera della commercializzazione all’ingrosso ed al dettaglio”.
Ha riconosciuto che esistono fenomeni illegali nel settore, ma che la maggior parte degli operatori lavora correttamente, creando occupazione e contenendo gli impatti ambientali. Quali sono le principali sfide che le imprese del riuso devono affrontare oggi in Italia?
“Il mercato del riuso non è dimensionalmente illimitato e subisce la concorrenza del super fast fashion cinese e gli effetti dell’’aumento dei quantitativi della raccolta, obbligatoria dal 2022 in Italia ed in tutta Europa entro il gennaio 2025. Questa situazione, unita l’aumento dei prodotti poco qualitativi del “fast fashion” che troviamo sempre più nei cassonetti ha fatto crollare il valore delle raccolte e sta saturando il mercato di sbocco. Mancano soluzioni industriali in grado di gestire in modo efficiente i grandi quantitativi in crescita della parte non riusabile proveniente dalle selezioni”.
In prospettiva, con l’introduzione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), cambierà la gestione degli abiti usati. Quali benefici concreti, secondo la sua esperienza da sindaco, porterà questa norma al sistema, alle imprese e alle città come Torino?
“L’istituzione del regime EPR per i prodotti tessili di abbigliamento, accessori e calzature determinerà la creazione di risorse finanziarie provenienti dell’ecocontributo che sarà compreso nel prezzo del nuovo e che tramite i Consorzi dei produttori ed in accordo con i Comuni consentirà di sostenere attività di riciclo oggi non realizzabili perché in perdita,oltre a garantire una maggiore regia complessiva a tutta la filiera. Non sarà facile, considerando la enorme disomogeneità sia dei tipi di prodotti ricompresi nella definizione di “rifiuto tessile” che della estrema varietà delle fibre tessili con le quali sono realizzati i capi, ma consentirà sicuramente una evoluzione complessiva del sistema che oggi vive un momento di grave difficoltà. Per quanto riguarda Torino, in attesa dell’EPR, stiamo valutando con Amiat possibili soluzioni migliorative per contrastare furti e degrado urbano da mettere in uso quanto prima”.
La vicenda dei cassonetti torinesi per gli abiti usati mette a nudo la fragilità di un sistema che dovrebbe incarnare l’economia circolare e la solidarietà urbana. L’allarme lanciato da Silvia Damilano ha riportato al centro un problema che da troppo tempo scorre sottotraccia; l’assessora Chiara Foglietta ne ha delineato numeri, obblighi europei e limiti strutturali. Ma è la voce di Andrea Fluttero che spazza via ogni residua ambiguità: dietro quei cassonetti forzati non c’è il bisogno di una maglia per affrontare l’inverno, ma una filiera criminale che svaluta il lavoro delle cooperative, sottrae risorse alla città e trasforma un gesto di civiltà in un vistoso segno di degrado.
Ed è qui che Torino si trova davanti a un passaggio decisivo. Perché una città che sperimenta progetti europei sul riuso, che ospita modelli virtuosi come “Abito”, che vuole proporsi come laboratorio di sostenibilità e innovazione sociale, non può accettare di essere rappresentata da mucchi di indumenti abbandonati ai piedi di un cassonetto. Non è solo una questione estetica: è la credibilità stessa dell’economia circolare a essere in gioco.
Fluttero lo ricorda con lucidità: la raccolta differenziata dei tessili non è beneficenza, ma una filiera industriale che crea occupazione, riduce l’impatto ambientale e genera valore. Perché questa filiera funzioni occorrono controlli più incisivi, un sistema di raccolta più resistente ai furti, cittadini informati e una regia istituzionale che metta ordine dove oggi esiste solo frammentazione.
Torino ha tutte le carte per trasformare una criticità in un’opportunità concreta: la sfida sarà decidere se lasciare che il degrado prenda il sopravvento o se restituire alla città - e ai suoi gesti quotidiani - il senso di responsabilità e cura che meritano.

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.