AGGIORNAMENTI
Cerca
Esteri
04 Novembre 2025 - 21:05

Camerun
La scena che si impone agli occhi non è quella di un seggio elettorale, ma di una strada polverosa. A Douala, la capitale economica del Camerun, le saracinesche sono abbassate, l’aria è pesante, impregnata di gas urticante. Un gruppo di ragazzi, zaini ancora in spalla, corre, disperdendosi in fretta dietro l’angolo. A migliaia di chilometri di distanza, a Dar es Salaam, in Tanzania, la scena è una fotocopia: striscioni strappati, internet che va a singhiozzo, telefoni muti. La voce che circola, sussurrata per strada, è la stessa: “Hanno già deciso”. E infatti, poche ore o giorni dopo, i risultati ufficiali arrivano.
In Camerun, Paul Biya, al potere dal 1982, vince per la sua ottava volta con il 53,66%. In Tanzania, Samia Suluhu Hassan, la prima presidente donna del paese, è proclamata vincitrice con un sorprendente 97,66%, un dato che somiglia più a un plebiscito che a un’elezione democratica. Gli osservatori lo ripetono da settimane: il voto è stato, per molti, una mera formalità. Ma la vera novità, la vera scossa, arriva dalla piazza. Una piazza giovane, che non vuole più restare a guardare.
La popolazione di questi paesi è tra le più giovani al mondo: in Camerun l'età mediana è di circa 18–19 anni, in Tanzania di 17,5. Metà della popolazione non aveva nemmeno memoria del mondo quando Biya governava già da decenni, o quando il partito di governo tanzaniano, il CCM, festeggiava un'altra vittoria "a tavolino". Questo paradosso demografico d'Africa — Paesi giovanissimi, governati da leader tra i più anziani del pianeta — non è solo un titolo da giornale, è la spina dorsale di una frattura che oggi è più visibile che mai.
In Camerun, Biya — l’uomo più anziano alla guida di uno Stato nel mondo — si appresta a varcare la soglia di un altro settennato. A Tanzania, la promessa di Samia Suluhu Hassan di una "nuova normalità" ha ceduto, nella campagna elettorale, alla logica del controllo. Ma mentre le urne venivano chiuse, le strade si riempivano di giovani che non ci stanno più. Non discutono solo il 53,66% di Biya, ma l’intero ecosistema politico che li ha esclusi. Vogliono una partecipazione vera, fatta di trasparenza, pluralismo, e fine dell’impunità per le violazioni delle forze di sicurezza.
Il 12 ottobre 2025, i camerunesi votano con la consapevolezza che il risultato è già scritto. Il 27 ottobre, il Consiglio costituzionale proclama Biya vincitore con il 53,66%, con un distacco di oltre 18 punti dall’ex alleato diventato rivale Issa Tchiroma Bakary, fermo al 35,19%. La reazione è immediata. Nelle città, la tensione si trasforma in scontri: Douala e Garoua sono teatro dei primi morti. La rete, nelle ore successive, comincia a cadere, segnala un monitor indipendente. La narrativa ufficiale del governo respinge le accuse di irregolarità, mentre l’opposizione denuncia brogli e proclama una vittoria "rubata".
Le organizzazioni per i diritti umani parlano di un uso eccessivo della forza: almeno quattro vittime documentate nelle prime giornate, centinaia di arresti, gas lacrimogeni e — secondo testimonianze video geolocalizzate — colpi d’arma da fuoco contro i manifestanti. Il 4 novembre, fonti interne all’ONU riferiscono di un bilancio ben più grave: 48 civili uccisi nelle repressioni post-elettorali. La risposta del governo è violenta, eppure la piazza non si ferma.
In Tanzania, il 29 ottobre 2025, si vota con risultati già scritti. Samia Suluhu Hassan vince con un incredibile 97,66%. I principali oppositori — tra cui le figure di spicco Tundu Lissu e Luhaga Mpina — non erano neppure presenti nelle schede. La sera del voto, la rete rallenta, poi si spegne completamente: blackout quasi totale, ripristinato solo in parte dopo cinque giorni. Nelle strade scoppiano proteste: coprifuoco, schieramenti militari, scontri con la polizia. Il governo minimizza. L’opposizione di CHADEMA parla di centinaia di morti in tre giorni. Le Nazioni Unite confermano “almeno 10” vittime e chiedono un'inchiesta indipendente sull’uso della forza. Amnesty International denuncia uccisioni illegali, arresti e sparizioni.
Ma la novità non sono tanto i risultati, quanto i protagonisti delle piazze. Giovani sotto i 30 anni — studenti, lavoratori precari, membri dell’economia informale — che hanno preso d’assalto le strade, i social, le piazze digitali. In Tanzania, alcuni ricercatori parlano della "Generazione Z" come il motore delle proteste, un movimento che ha infranto il muro della paura costruito negli anni. In Camerun, i giovani chiedono una nuova grammatica della partecipazione: più trasparenza, più pluralismo, meno impunità. "Non abbiamo mai conosciuto un altro presidente", ripetono.
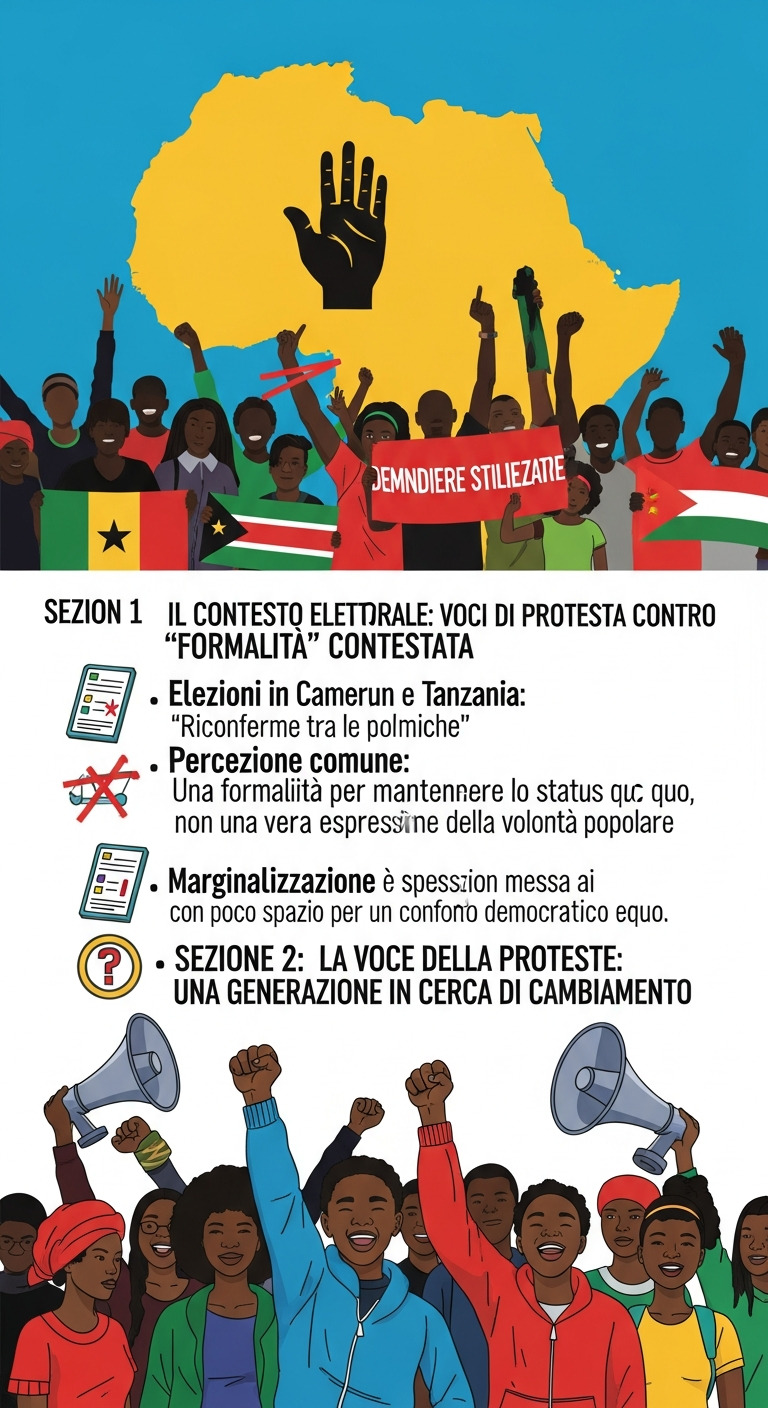
Se la politica istituzionale appare bloccata, la società cambia linguaggio. Nei quartieri periferici di Yaoundé, come nelle zone difficili di Dar es Salaam, comitati civici si organizzano dal basso. Si alimentano di video e geolocalizzazioni, ricostruendo dinamiche e orari, e sfidano la narrativa ufficiale. La battaglia per l’informazione è diventata cruciale: i blocchi di rete sono ormai il principale strumento di repressione. In Camerun, le interruzioni “selettive” nei giorni decisivi, in Tanzania il blackout totale, hanno lo stesso obiettivo: isolare la piazza, rendere invisibili gli abusi.
Gli apparati elettorali possono annunciare risultati, numeri e percentuali, ma per una larga parte della cittadinanza — soprattutto quella giovane — la sostanza manca: accesso equo ai media, scrutini trasparenti, osservatori indipendenti. In Camerun, la "macchina Biya" è un sistema che sopravvive ai cicli storici: fedeltà amministrative, controllo delle leve politiche, cooptazione degli sfidanti. In Tanzania, la lunga permanenza del CCM al potere non è di per sé una colpa. Il problema è l'uso sistematico di leggi e divieti per comprimere lo spazio civico e politico, svuotando il confronto democratico.
Ma non è la società a restare immobile. La forza delle proteste del 2025, sia a Yaoundé che a Dodoma, indica una cosa chiara: la legittimazione non si misura più solo sui numeri. Si misura sulla capacità di dialogare con una società che chiede diritti, lavoro, e servizi. La retorica della stabilità si scontra con una realtà che chiede cambiamento.
Le organizzazioni internazionali hanno espresso preoccupazione per la repressione in corso. ONU, Unione Europea, Amnesty International e altre ONG chiedono indagini indipendenti, il rilascio degli arrestati per proteste pacifiche, e la fine dei blocchi di rete. Ma questi messaggi non hanno cambiato la realtà sul terreno. E allora nasce una domanda inevitabile: la diplomazia deve superare le formule di rito e legare aiuti e partenariati a standard minimi di libertà civili e pluralismo? In questi paesi, crocevia di sicurezza regionale, migrazioni, e investimenti energetici, la tentazione di privilegiare la stabilità a breve termine sulla democrazia è forte. Eppure, la storia recente ci insegna che la stabilità senza diritti è una promessa che si smentisce da sola.

Le richieste, per ora, incontrano due ostacoli. Il primo è istituzionale: senza organismi davvero indipendenti — dalla giustizia all’autorità elettorale — ogni protesta rischia di arenarsi. Il secondo è informativo: il controllo della rete e la disinformazione abbattono la fiducia e isolano i cittadini tra loro. Eppure, proprio l’uso creativo di strumenti digitali da parte di studenti e attivisti — mappe, archivi, live verificati — sta riaprendo varchi nella narrazione ufficiale.

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.