AGGIORNAMENTI
Cerca
Attualità
09 Maggio 2025 - 21:57

La conferenza dell’Unitre di Cuorgnè, tenuta dalla docente Daniela Giannone la scorsa settimana è stata una lezione preziosa su un tema che ci riguarda tutti, prima o poi: la fragilità. Fragile, dal latino frangere – spezzare –, non è solo una condizione fisica o mentale, ma uno stato che può attraversare ciascuno di noi, anche solo per un periodo limitato. Si può essere fragili per un lutto, una malattia, una crisi emotiva o semplicemente per il passare del tempo. Oggi basta avere più di 65 anni per essere considerati “anziani”, e dunque, in modo implicito, vulnerabili.
Secondo Giannone, però, la fragilità non coincide con l’incapacità giuridica. Il nostro ordinamento, almeno fino al 2004, riconosceva solo due forme di protezione: l’interdizione per chi era del tutto incapace e l’inabilitazione per chi lo era solo parzialmente. Entrambe erano previste dal Codice Civile del 1942 e richiedevano un procedimento giudiziario lungo e costoso. La tutela era garantita solo dopo un processo, una perizia e una sentenza. Solo per i maggiorenni. Solo se ritenuti “incapaci”. Un meccanismo che escludeva una grande parte della popolazione fragile, ma ancora “capace” in senso formale.
Giannone ha portato l’esempio di una signora anziana che, a causa di una demenza iniziale, firma un contratto per acquistare un’enciclopedia, con rate equivalenti alla sua intera pensione. Nessuna truffa. Solo un’incapacità di valutare le conseguenze economiche. Ma se non c’è un provvedimento di interdizione, l’annullamento del contratto richiede una causa civile e la dimostrazione che, al momento della firma, la donna era in uno stato di alterazione mentale temporanea. Una strada in salita. Costosa. E per molti, impraticabile.
L’inabilitazione, oggi quasi dimenticata, era invece usata nei casi di prodigalità, alcolismo o tossicodipendenza, ovvero quando una persona, pur non essendo legalmente incapace, metteva in pericolo il proprio patrimonio e quello della sua famiglia. Non si trattava necessariamente di patologie: una persona abituata a una vita agiata, che continua a spendere come prima nonostante abbia perso le sue entrate, rientra nella categoria dei “prodighi”. Come la signora torinese che faceva acquisti da cima a fondo in via Roma, e che rischiava, nel giro di dieci anni, di restare senza nulla. Lo Stato è intervenuto non per giudicare il suo stile di vita, ma per evitare che diventasse indigente, a carico della collettività.
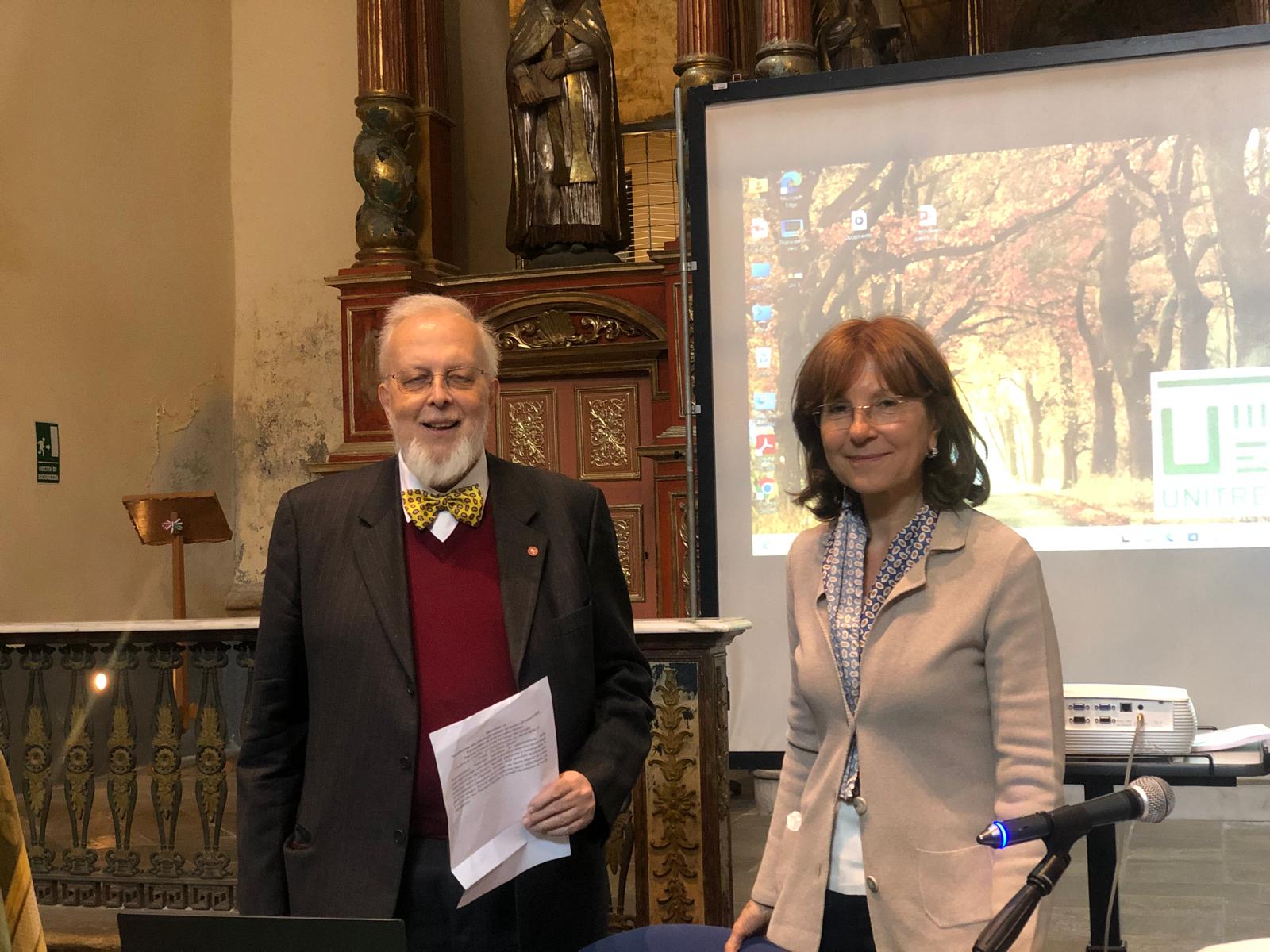
La parola interdetto – spiega Giannone – è brutta: significa “ti tolgo la parola”. Ma in realtà è il tutore che presta la propria voce alla persona fragile. Non è una sottrazione violenta, è un atto di rappresentanza. Eppure, il termine resta stigmatizzante. Sarebbe stato più utile parlare di “amministrazione di protezione”, una definizione che avrebbe forse evitato l’opposizione diffusa all’istituto dell’interdizione. Perché senza questi strumenti, molti non vivrebbero. Sopravviverebbero malamente.
Il punto di svolta è arrivato nel 2004 con la legge sull’amministrazione di sostegno, finalmente pensata per chi si trova in difficoltà temporanee o parziali. L’amministratore di sostegno affianca la persona solo per gli atti indicati dal giudice: un affitto, una pratica INPS, il pagamento delle bollette. Per tutto il resto, l’amministrato conserva la propria capacità. La misura è flessibile e personalizzabile. Esempi concreti? Il signor Carlo, rimasto vedovo, ha difficoltà con i computer e con le pratiche telematiche. Oppure Maria, che dimentica di pagare il canone di locazione, rischiando di perdere la casa. O ancora Piero, con un lieve ritardo cognitivo, che ha bisogno di un supporto minimo per gestire un patrimonio familiare ereditato dalla madre.
L’amministratore può essere un parente, un assistente sociale, un volontario, un professionista. A Torino esiste un ufficio chiamato “fasce deboli” presso la Procura, dove operatori sociali raccolgono le istanze e le inviano al giudice tutelare. Il ruolo dell’amministratore è chiaro: non può fare tutto. Deve rappresentare, non sostituire. Se nasce un conflitto, interviene il giudice.
Ma che succede quando si tratta di decidere per la salute? Quando entra in gioco il consenso informato? Qui la docente ha evocato il caso che ha scosso l’Italia: Eluana Englaro. In coma vegetativo dal 1992, dopo tredici anni il padre Peppino, suo tutore, chiese al tribunale l’autorizzazione a sospendere l’alimentazione artificiale. Inizialmente la domanda fu respinta: si trattava di un atto personalissimo, come il diritto a morire, che nemmeno un tutore poteva esercitare. L’alimentazione forzata era considerata “dovuta”. Ma la Corte d’Appello ribaltò la sentenza: curare una persona significa anche rispettarne la volontà, anche se espressa quando era capace. La Cassazione, nel 2007, accolse il ricorso: l’alimentazione e l’idratazione artificiale, in assenza di benefici, possono diventare accanimento terapeutico. Eluana, secondo i testimoni, aveva più volte affermato che non avrebbe mai voluto vivere in quello stato. Il tutore, quindi, non decide in nome proprio, ma ricostruisce e fa valere la volontà della persona tutelata. È questo il punto centrale: non si tratta di sostituirsi alla volontà del malato, ma di garantirne il rispetto anche dopo la perdita di coscienza.
Il caso Englaro portò, nel 2017, all’approvazione della legge sul testamento biologico, che riconosce a ogni persona maggiorenne la possibilità di depositare presso il Comune le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). In esse, si possono indicare le terapie che si vogliono accettare o rifiutare, e nominare un fiduciario che ne garantisca il rispetto. È un diritto ancora poco conosciuto, denuncia Giannone: i Comuni e le ASL dovrebbero informare di più, creare sportelli divulgativi, usare i media. La modulistica esiste, ma non tutti sanno che basta recarsi all’anagrafe, oppure scaricare i moduli da Internet. Se non si nomina un fiduciario, o se questi rifiuta l’incarico, vale quanto dichiarato e il giudice può nominare un amministratore di sostegno ad hoc.
Secondo la docente, oggi il 60% delle misure adottate sono amministrazioni di sostegno. L’inabilitazione è ormai residuale, mentre l’interdizione riguarda circa il 30% dei casi. Lo Stato è molto più attento rispetto al passato, ma restano ampi margini di miglioramento. Il problema non è la legge – che ora c’è – ma la sua applicazione concreta, la conoscenza e la cultura della protezione.
In conclusione, Giannone ci ha lasciato con un’immagine che vale più di mille definizioni: crediamo di essere forti come la roccia, ma alla prima avversità ci scopriamo fragili come petali o vetro. E proprio per questo, oggi più che mai, serve una società che sappia vedere nella fragilità non un ostacolo, ma una dignità da difendere.
Edicola digitale
I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.