AGGIORNAMENTI
Cerca
Attualità
01 Maggio 2025 - 15:23

Dal “fico secco” al “sorriso sardonico”: viaggio curioso tra i modi di dire italiani
Durante la conferenza del 30 aprile all’Unitre di Cuorgnè ho illustrato come in ogni lingua esistano frasi curiose, i cosiddetti modi di dire, che utilizziamo quotidianamente comprendendone il significato, ma che, se analizzati nella loro forma letterale, risultano piuttosto bizzarri. Perché, ad esempio, essere al verde dovrebbe indicare una mancanza di denaro? Cosa c’entra il colore verde con la mia situazione economica? La risposta è semplice: molti modi di dire affondano le radici in usanze, contesti storici o tradizioni ormai lontane, che ne hanno determinato il senso figurato.
E allora, bando alle ciance! Questo modo di dire risale all’epoca medievale: bando, dal latino bannum, era un ordine ufficiale; ciancia deriva da un termine dialettale che significa chiacchiera inutile. Quindi, l’espressione era un invito autorevole a smettere di parlare a vuoto. Non a caso, divenne comune nei contesti nobiliari, spesso affollati di discorsi pomposi e inconcludenti.
Non è mia intenzione fare un panegirico – parola che deriva dall’antica Grecia e indicava un discorso celebrativo pubblico – ma semplicemente esplorare alcune espressioni e le loro origini.
Ad esempio, il quarto d’ora accademico: una tradizione universitaria per cui le lezioni iniziavano quindici minuti dopo l’orario ufficiale, lasciando tempo a studenti e docenti per raggiungere l’aula, spesso guidati dal suono delle campane cittadine.
E ancora: fare il terzo grado, espressione che richiama gli interrogatori ai maestri templari, detti appunto terzo grado. Oppure andare di palo in frasca, metafora medievale del passare da un contesto nobiliare (il palo, segno araldico) a uno popolare (la frasca, insegna delle osterie).
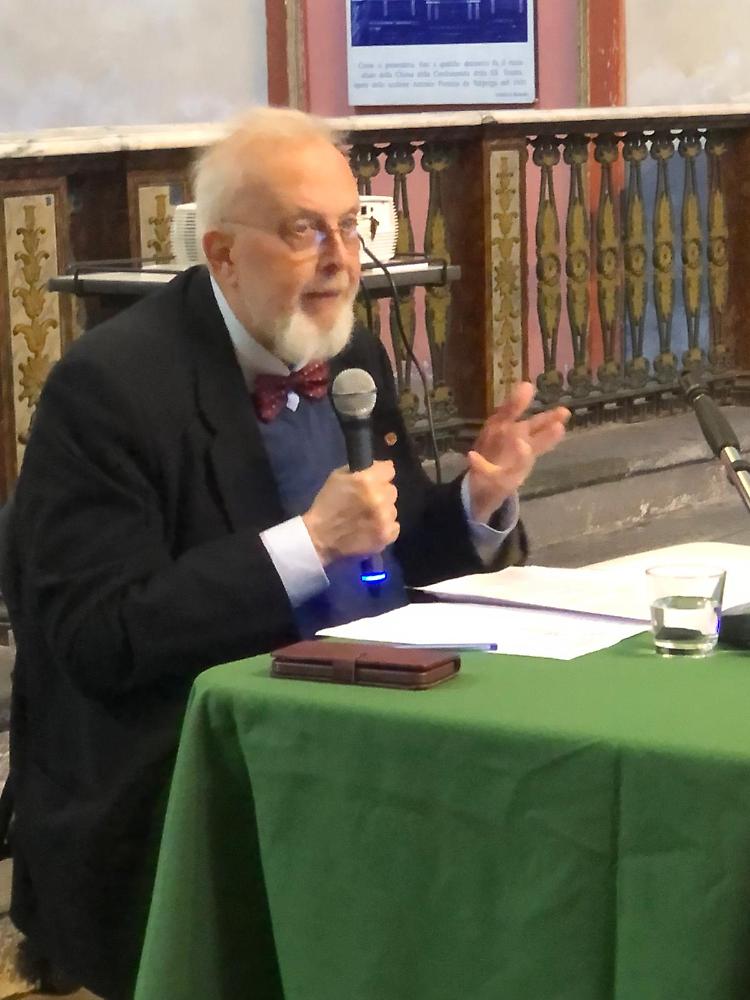
Giorgio Cortese
Facciamo alla romana? – espressione conviviale che evoca l’abitudine di dividere equamente il conto, forse nata dalle “romanate”, scampagnate campestri a base di cibo e vino.
“Tutte le strade portano a Roma” è invece eredità del sistema viario romano, che partiva dalla capitale; pietra miliarederiva dai cippi posti lungo queste vie. Entrambe oggi indicano punti di riferimento, strade metaforiche e tappe fondamentali della vita.
Vecchio come il cucco – forse dal profeta biblico Abacuc, oppure dal cuco, un antico fischietto in terracotta. Mentre mandare a Patrasso – dal luogo della disfatta veneziana – è diventato sinonimo di “mandare in rovina”.
Perdere la Trebisonda, invece, evoca la città portuale dell’attuale Turchia, un tempo importante punto di riferimento per i marinai: quando scompariva nella nebbia, si perdeva l’orientamento.
Avere una brutta cera non si riferisce alla cera delle candele, ma al greco kára, ovvero “faccia”. Similmente, perdere le staffe richiama il cavaliere che, privo di appoggio, perde l’equilibrio.
Espressioni come uscire dai gangheri o perdere la tramontana condividono la medesima idea di perdita di controllo. Quest’ultima deriva dalla direzione dei venti, in particolare la tramontana, ossia il nord.
Avere il vento in poppa, invece, è un’immagine positiva che arriva dal mondo della navigazione, come anche gridare ai quattro venti, ovvero rendere qualcosa noto a tutti.
Piantare in asso rimanda all’abbandono di Arianna da parte di Teseo sull’isola di Nasso, divenuto Asso per corruzione linguistica. Le calende greche invece non esistevano: da qui l’idea di rinviare a mai.
Non avere voce in capitolo viene dalle assemblee monastiche, dove solo alcuni potevano parlare. E passare dalla rava alla fava? Significa trattare ogni minimo dettaglio: da noi in Piemonte, la rava è la rapa, ingrediente base del minestrone.
Legarsela al dito trae origine da antiche usanze religiose e amorose; mentre fare un quarantotto è una diretta eredità dei moti rivoluzionari del 1848. Essere lapalissiano? Tutto parte da una canzone dedicata al maresciallo La Palice, morto a Pavia: se non fosse morto, sarebbe ancora in vita…
Indorare la pillola è un’immagine farmaceutica, mentre fare orecchie da mercante nasce dal comportamento dei commercianti medievali. Tempi biblici sono ovviamente lunghi, come i racconti della Genesi.
Fare il bucato viene dal francone bukon, lavare; fare un buco nell’acqua evoca invece l’inutilità. Arrivare sul filo di lana è figlia delle prime Olimpiadi moderne: si spezzava un filo all’arrivo per decretare il vincitore.
Cercare un ago nel pagliaio, rimanere in braghe di tela, parlare a vanvera… Tutte immagini colorite che, nel loro senso figurato, raccontano scene quotidiane, storiche o semplicemente folkloristiche.
Farsi infinocchiare risale all’uso romano di offrire semi di finocchio per mascherare la qualità del vino. Mettere alla berlina o alla gogna erano vere pene pubbliche, oggi trasformate in giudizi mediatici.
Non valere un fico secco? I legionari ne ricevevano come paga. Gabinetto, oggi luogo di potere oltre che di igiene, deriva dalle stanze riservate dei reali inglesi.
Seminare il panico è figlio del dio Pan e delle sue urla nei boschi. Sorriso sardonico deriva da una pianta tossica. E episodio rocambolesco? Omaggio a Rocambole, eroe spericolato dei romanzi francesi.
Menare il can per l’aia e fare le ore piccole sono espressioni contadine e cittadine, rispettivamente. Passare un brutto quarto d’ora si ispira a un inganno escogitato dallo scrittore Rabelais.
Dire le cose papale papale richiama la chiarezza delle parole pontificie; bicchiere della staffa è l’ultimo brindisi prima di congedarsi. Prendere una crina pericolosa si riferisce alle creste montuose più esposte.
Capostipite richiama il tronco dell’albero genealogico; toccare ferro ha origini medioevali, ma anche una leggenda su San Dunstano e il diavolo. Tallone d’Achille è l’archetipo del punto debole.
Fare un putiferio ricorda il caos provocato dalla moglie di Putifarre. Fare il gradasso e fare il sacripante vengono da personaggi letterari millantatori e muscolosi.
Due di picche, non contare niente, essere rifiutati: anche le carte da gioco diventano modi di dire. Non avere sale in zucca, invece, è sinonimo di mancanza di saggezza.
Calzare a pennello forse nasce dall’immagine pittorica di un abito perfettamente aderente. Tirapiedi era l’aiutante del boia, figura servile. Camera ardente prende il nome dalle torce accese accanto al defunto.
Far vedere i sorci verdi è un riferimento a una squadriglia della Regia Aeronautica. Un altro paio di maniche nasce dalle maniche intercambiabili dell’abito medievale. Da lì anche essere di manica larga, ovvero indulgenti, come i frati confessori.
Essere sul pezzo richiama la catena di montaggio; chiudere baracca e burattini i teatranti di strada. La nostra lingua è un tesoro mutevole e vastissimo – il dizionario di Tullio De Mauro conta oltre 260.000 lemmi – capace di cogliere ogni sfumatura emotiva.
Eppure, troppo spesso ignoriamo la potenza delle parole. Più ne conosciamo, più possiamo pensare, esprimere e ottenere.
Un grazie sentito a Giovanni Usai per i raffinati intermezzi al pianoforte.
ALTRI ARTICOLI DI GIORGIO CORTESE QUI
Edicola digitale
I più letti
Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.