AGGIORNAMENTI
Cerca
Attualità
29 Gennaio 2026 - 08:46

Ieri sera, 28 gennaio, Torino aveva addosso quell’aria particolare che accompagna le serate destinate a lasciare un segno. Non l’euforia delle grandi feste né la ritualità delle commemorazioni, ma una tensione composta, quasi vigile. Quella che si respira quando anche un appuntamento culturale deve essere protetto, organizzato, presidiato. Come se le parole, prima ancora dei fatti, potessero diventare pericolose.

Il titolo dell’incontro non lasciava spazio ad ambiguità: “Democrazia in tempo di guerra” e il sottotitolo, “Censurare l’informazione, disciplinare la cultura e la scienza”, chiariva subito che non si trattava di una semplice conferenza, ma di una presa di posizione. Sul palco del Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini, i due storici, professori universitari e intellettuali torinesi Angelo D’Orsi e Alessandro Barbero hanno finalmente tenuto la conferenza che era stata bloccata il 9 dicembre 2025, riportandola nello spazio pubblico da cui era stata esclusa.
Da Torino è partita così una diretta che aveva il sapore di una restituzione collettiva. Non solo un evento recuperato, ma un gesto simbolico. Gli organizzatori lo avevano chiarito fin dall’inizio, fissando una cornice che ieri sera ha trovato conferma nei fatti: “Intanto, i tentativi di censura sono diventati più diffusi e aggressivi”, han fatto sapere gli organizzatori. Non un’iperbole, ma una constatazione che spiegava sia la partecipazione massiccia sia le misure di sicurezza visibilmente rafforzate.
Dentro questa cornice, il nodo non era un singolo episodio, ma una traiettoria politica e culturale più ampia: “Sempre più forte, perciò, è l’esigenza di impedire la guerra alla Russia che ci si vuole imporre come difesa: è la democrazia che va difesa, con la libertà di pensiero e la verità storica”. E la conclusione, netta, quasi programmatica: “L’Italia ha bisogno non di guerra, ma di pace, non di armi, ma di servizi sociali, di istruzione, di sviluppo”.

Nel corso dell’evento, è stato inoltre rilanciato l’invito a partecipare alla manifestazione nazionale in programma a Torino il 31 gennaio 2026, una mobilitazione promossa da una rete di collettivi, spazi sociali, realtà associative e movimenti civici, nata in risposta allo sgombero del centro sociale Askatasuna e più in generale contro il governo, la guerra e l’attacco agli spazi di dissenso. Un appuntamento che, nelle intenzioni dei promotori, vuole portare fuori dalle sale e nelle piazze la difesa della democrazia, della libertà di espressione e del diritto al conflitto sociale, proseguendo sul terreno pubblico il confronto aperto al Palazzetto di Parco Ruffini.

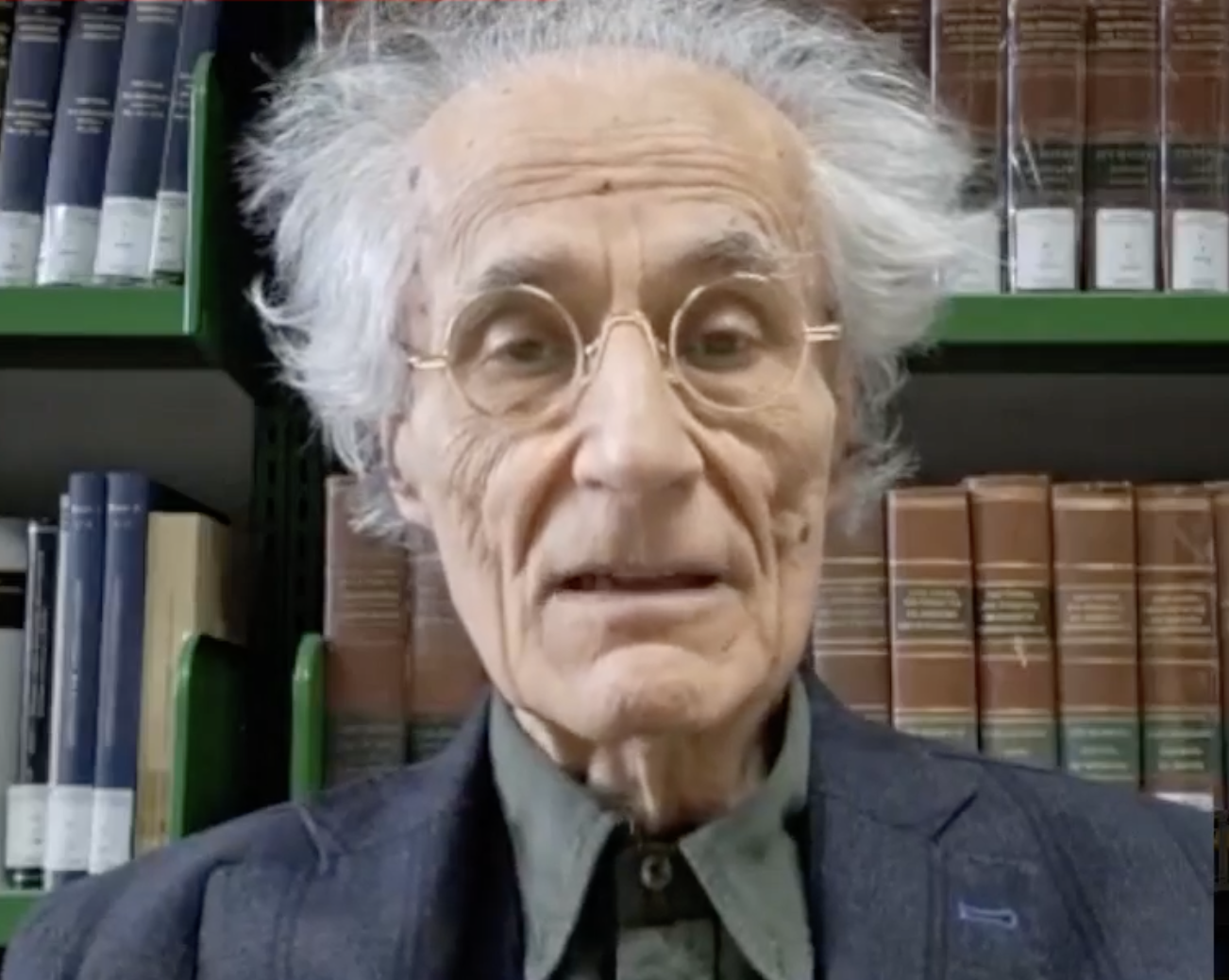

La risposta di Alessandro Barbero ha allargato il quadro storico: Oggi, ha spiegato, le guerre non hanno più bisogno di essere proclamate: “In genere le guerre, ormai, si fanno senza dichiararle”. Poi è arrivata una riflessione pronunciata quasi come una confessione, capace di attraversare la sala: “Mi viene sempre un brivido quando un capo di Stato dice ‘Siamo in guerra’, perché in realtà sta dicendo: ‘Possiamo adottare misure straordinarie e voi dovrete obbedire’”.

Da lì, Barbero ha messo a fuoco il paradosso contemporaneo: “In questo senso non è nemmeno del tutto vero che oggi non ce lo dicano: ce lo fanno capire, ce lo dicono sotto traccia, ci suggeriscono che siamo in guerra”. Ma senza mai assumersene fino in fondo la responsabilità politica e giuridica: “Non l’hanno dichiarata”. Una scelta che, ha ricordato lo storico, non è affatto casuale: “Dichiarare formalmente una guerra è passato di moda dopo il 1945. Oggi le guerre si combattono senza più proclamarle”.

Il direttore de il Fatto Quotidiano ha quindi messo il dito nella piaga con una domanda brutale: “Sono così stupidi da non rendersi conto di essere stupidi?”, per poi spostare il discorso su un piano più inquietante: “Oppure sono costretti alla censura? Io penso che siano soprattutto costretti alla censura”.
Travaglio ha inoltre ricostruito con dovizia di esempi quattro anni di narrazioni contraddittorie sulla guerra in Ucraina, mostrando come la propaganda abbia cambiato pelle più volte senza mai preoccuparsi della coerenza. Da un lato, ha ricordato, Vladimir Putin veniva descritto come un leader malato, con “tre o quattro cancri” e “i giorni contati”; dall’altro, la Russia veniva dipinta come una potenza militare inarrestabile, pronta a travolgere l’Europa. Un racconto schizofrenico che, secondo Travaglio, avrebbe dovuto far scattare il sospetto ben prima: eserciti allo sbando che combattevano “con le pale”, soldati senza calzini e microchip sottratti alle lavatrici, salvo poi trasformarsi improvvisamente in una minaccia tale da giustificare 800 miliardi di euro di riarmo europeo.
Da qui il passaggio cruciale: la censura non è un errore, ma uno strumento funzionale. Serve a “tenere ferma la popolazione”, mentre si spostano risorse pubbliche verso l’industria degli armamenti e si scoraggia qualsiasi forma di dissenso o di domanda scomoda. E quando la propaganda mostra le sue crepe, come nel caso delle sanzioni “micidiali” o delle presunte invasioni russe imminenti, invece di correggersi, si irrigidisce, moltiplicando i divieti e l’oscuramento delle voci critiche.
La conclusione è arrivata come una sintesi brutale dell’intero ragionamento. Il modello, secondo Travaglio, è già sotto gli occhi di tutti: “È la regola Netanyahu applicata all’Europa”.

Il collegamento con Francesca Albanese ha spostato l’attenzione su Israele e Palestina, indicati come termometro dello stato di salute delle democrazie occidentali. Parlare di Palestina, ha sottolineato d’Orsi subito dopo l'intervento della giurista, è diventato quasi impossibile. E ha usato un’immagine tagliente citando Liliana Segre: “È come Padre Pio: non si può criticare”.
Sul biglietto, un QR code

Edicola digitale
I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.