AGGIORNAMENTI
Cerca
Attualità
10 Ottobre 2025 - 21:42

Dai manicomi alle Rems: il sistema che non funziona e l'esempio di San Maurizio Canavese
È riesploso il dibattito sulle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dopo l’ennesimo episodio di cronaca nera che ha riportato sotto i riflettori una questione che l’Italia non riesce a risolvere da anni. A San Nicola Baronia, un piccolo comune in provincia di Avellino, un uomo di sessant’anni originario del Beneventano è morto dopo una lite con un altro paziente all’interno della struttura. Una tragedia che ha riacceso le polemiche su un sistema nato per superare gli orrori degli ex ospedali psichiatrici giudiziari, ma che oggi mostra tutte le sue crepe. I numeri parlano chiaro: posti insufficienti, liste d’attesa interminabili, tensioni crescenti tra giustizia e sanità. E soprattutto, vite sospese.
A dieci anni dalla chiusura degli Opg, il bilancio è tutt’altro che positivo. Di Rems in Italia ce ne sono una trentina, con circa 680 posti a disposizione e oltre 700 persone in attesa di essere accolte. Persone che, per decisione del giudice, non possono tornare in libertà ma neppure restare in carcere, perché il loro reato è stato commesso in stato di incapacità di intendere e di volere. In teoria, dovrebbero essere curate. In pratica, molte restano per mesi – in alcuni casi oltre un anno – negli ospedali civili o nei penitenziari, in attesa che si liberi un posto. Succede ovunque, da nord a sud, e la tragedia di San Nicola Baronia è solo l’ultima spia di un sistema arrivato al limite.
Il tema è stato al centro anche del convegno di Genova dal titolo “Ripensare l’imputabilità”, organizzato all’inizio di ottobre, dove magistrati, psichiatri e operatori hanno tracciato un bilancio di questi dieci anni. La sintesi è amara: le Rems non bastano, ma non basta nemmeno costruirne di nuove. Serve una riforma vera, capace di tenere insieme il diritto alla cura e la sicurezza dei cittadini. Durante il convegno è intervenuto anche il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha rilanciato l’allarme con un documento ufficiale: “Non possiamo continuare a trattare la malattia mentale come un problema penale, servono strumenti adeguati e una rete territoriale che accompagni queste persone fuori dal circuito giudiziario”. Parole che arrivano dopo mesi di denunce da parte di giudici di sorveglianza e direttori sanitari, spesso costretti a “inventarsi” soluzioni provvisorie di fronte alla mancanza di posti disponibili.
La Corte costituzionale, già nel 2022, aveva ammonito il Parlamento, definendo la situazione delle Rems “una lesione dei diritti fondamentali” e invitando a intervenire con urgenza per eliminare i conflitti di competenze tra giustizia e sanità. Ma da allora poco o nulla è cambiato. Ogni regione gestisce le proprie strutture come può, spesso con personale ridotto e protocolli differenti. Alcune, come la Toscana, hanno in cantiere nuove aperture, ma i lavori procedono a rilento tra ostacoli burocratici e resistenze locali. Nel frattempo, gli operatori raccontano di giornate impossibili, turni massacranti e pazienti sempre più difficili da gestire.
Eppure le Rems nascono da un’idea profondamente umana. Dovevano rappresentare la chiusura definitiva di una stagione buia, quella dei manicomi criminali, in cui la pena si confondeva con la malattia. Dovevano essere luoghi di cura, non di reclusione. In teoria accolgono persone affette da disturbi psichici autrici di reato, dichiarate non imputabili e pericolose per sé o per gli altri. La misura di sicurezza, che un tempo veniva eseguita negli Opg, oggi si svolge in queste strutture sanitarie gestite dalle Asl, sotto la vigilanza del sistema giudiziario. Ma la distanza tra la teoria e la realtà quotidiana resta enorme.
Il sistema mostra falle strutturali: troppe differenze tra regioni, pochi psichiatri forensi, carenza di formazione e risorse economiche limitate. E così la promessa di un modello innovativo si è trasformata, come hanno detto molti esperti, in una riforma a metà. Il risultato è che le Rems si trovano oggi schiacciate tra due logiche: quella sanitaria, che vorrebbe puntare alla riabilitazione, e quella giudiziaria, che pretende controllo e sicurezza. Due mondi che raramente dialogano, lasciando in mezzo un limbo fatto di attese e sofferenze.
Nonostante tutto, il tema resta marginale nel dibattito politico nazionale. Solo dopo tragedie come quella di San Nicola Baronia se ne torna a parlare, salvo poi archiviare tutto fino alla prossima emergenza. Eppure dietro ogni caso ci sono persone, famiglie, operatori e comunità intere che convivono con un sistema che rischia di tradire il suo stesso principio fondatore: curare senza punire. In questi giorni, mentre si moltiplicano gli appelli del Csm, delle regioni e delle associazioni di psichiatria forense, qualcuno torna a chiedersi se le Rems abbiano davvero realizzato ciò che promettevano. Oppure se, chiusi gli Opg, l’Italia abbia solo cambiato il nome alle sue vecchie prigioni.
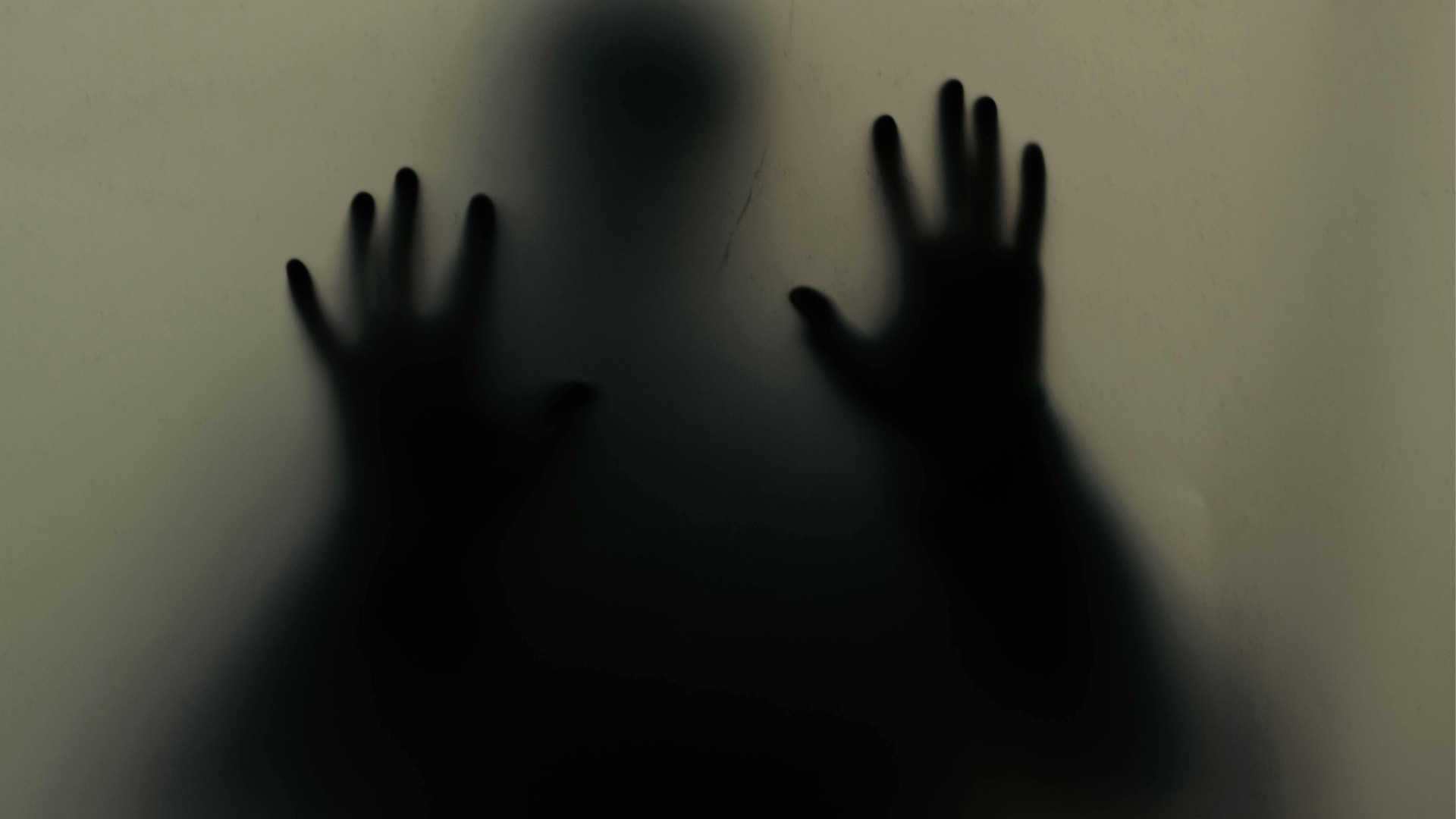
Il Piemonte è una delle regioni che meglio raccontano la complessità del sistema delle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie nate per accogliere malati psichiatrici che hanno commesso gravi reati, anche di sangue, ai quali la magistratura ha riconosciuto un parziale o totale vizio di mente e che sono considerati socialmente pericolosi. Non si tratta dunque di carceri, ma di luoghi in cui il principio non è più quello della punizione bensì della cura.
Il numero di queste strutture in Italia resta tuttavia scarso rispetto al fabbisogno, tanto che l’Unione Europea ha sanzionato il nostro Paese per l’inadeguatezza del sistema. In Piemonte ce ne sono due: una a San Michele di Bra, nel Cuneese, e una a San Maurizio Canavese, alle porte di Torino. Nella Rems di San Maurizio i posti letto sono venti, che diventano quaranta se si considerano anche quelli della Comunità psichiatrica forense, dove i pazienti che hanno completato la prima parte della riabilitazione proseguono il cammino verso il reinserimento sociale.
Le Rems, a differenza dei vecchi manicomi criminali, non dipendono più dal Ministero della Giustizia ma dalle Asl territoriali. È quindi la sanità, e non la detenzione, a guidare il percorso terapeutico. Questa trasformazione, però, ha comportato anche una riduzione delle risorse economiche, tanto che i posti disponibili in Italia — circa 1.400 nei primi anni Duemila — oggi sono dimezzati. Un taglio che pesa su un sistema già fragile, dove il confine tra sicurezza e riabilitazione è sempre più sottile.
A San Maurizio Canavese, la Rems “Anton Martin” rappresenta un modello di riferimento. A dirigerla è il professore Alessandro Jaretti Sodano, psichiatra con oltre quarant’anni di esperienza, che coordina un’equipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, educatori, assistenti sociali, infermieri e operatori socio-sanitari. L’équipe segue venti pazienti, uomini e donne, all’interno di una struttura che comprende una zona diurna dedicata alle attività ludico-ricreative e una zona notturna con le camere da letto.
Al centro del modello piemontese c’è proprio questa equipe multiprofessionale, vero cuore pulsante della Rems. A San Maurizio, dove sono accolte persone con storie complesse e talvolta violente, è presente anche una figura particolare: l’operatore di sicurezza interna. Non si tratta di vigilanti o agenti penitenziari, ma di professionisti che garantiscono il rispetto delle regole e la serenità degli ospiti, con un ruolo ben definito all’interno del progetto riabilitativo. La sicurezza, qui, non è controllo ma accompagnamento.
La Rems “Anton Martin” di San Maurizio Canavese esiste dal 2016, e la degenza media di ogni paziente non supera i 600 giorni. In molti casi, chi ha concluso con successo il percorso di cura e riabilitazione è tornato nella struttura come lavoratore, un segno concreto di riscatto e reinserimento sociale. È un risultato che racconta lo spirito del modello piemontese, fondato sulla convinzione che anche chi ha sbagliato — e perfino chi è stato giudicato socialmente pericoloso — meriti una seconda possibilità.
In Piemonte questo spirito trova la sua espressione più autentica a San Maurizio Canavese, dove lo stile dei Fatebenefratelli si traduce in quattro parole chiave: accogliere, ascoltare, accompagnare, affidare. È il filo conduttore di un lavoro che unisce rigore scientifico e umanità, sicurezza e fiducia, responsabilità e speranza. Qui, dietro le mura silenziose di una struttura immersa nel verde, si tenta ogni giorno di trasformare la follia e la colpa in una possibilità di rinascita.
Edicola digitale
I più letti
Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.